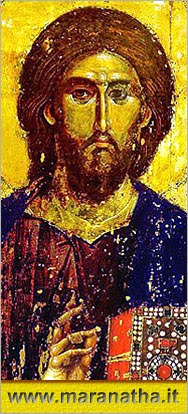LA CHIESA “À LA CARTE”
di Francesco Arzillo
L’osservatore di cose ecclesiali non rimane certamente disoccupato di questi tempi: i dibattiti abbondano, dalla sempre incombente “questione-macigno” relativa all’interpretazione del Vaticano II, fino alle più sottili problematiche di etica sessuale, che fino a cinquant’anni fa sarebbero rimaste chiuse nei testi di teologia morale e nei riservati avvisi del Sant’Offizio o della Penitenzieria.
Ma qual è il contesto nel quale questi dibattiti si collocano? La risposta si pone su un duplice piano e non ci sembra confortante.
Consideriamo innanzitutto il piano epistemologico. È ben noto, a tutti quelli che frequentano queste problematiche, il fatto che gli studi teologici abbiano subito negli ultimi decenni una torsione epistemologicamente negativa, non tanto e non solo nel contenuto, quanto nel metodo.
Il venir meno della percezione del necessario nesso tra una filosofia realistica di stampo metafisico e l’elaborazione teologica ha portato al dilagare di approcci di tipo fenomenologico-ermeneutico, con la conseguente diminuzione dell’attenzione alla questione della verità in teologia. Molte elaborazioni attuali, pur non prive di interesse ed esteriormente ortodosse, risuonano nel vuoto pneumatico della carenza di un’ontologia di base: risuonano cioè come affermazioni prive di referente reale, tecnicamente inteso. Il che, per una teologia che dovrebbe illustrare una fede basata su fatti storici, non pare un difetto da poco.
Ad esempio, molti teologi assumono – a volte in maniera francamente dilettantistica – le suggestioni della fenomenologia dell’amore, ritenendo di superare le precedenti concezioni perché troppo dottrinalistiche e “sostanzialistiche”. Essi credono di collocarsi nello spirito del Vaticano II, mentre quest’ultimo richiama San Tommaso non a caso, trattandosi di un pensatore che ha tenuto nel massimo conto la necessità di fare una teologia supportata da un’accurata e coerente ontologia filosofica.
Se poi si viene al campo della teologia morale, questi difetti risultano ancora più evidenti, anche perché la casistica – che oggi sembra rinascere sulla questione del profilattico – è in realtà ritenuta metodologicamente desueta da molti; e pure qui non a caso, perché essa supponeva e suppone non vaghi personalismi ed estetiche valoriali, ma solidi principi di ontologia e logica filosofica.
Ma c’è dell’altro. Tutti questi dibattiti si inseriscono in un contesto mediatico che amplifica la tendenza alla “Chiesa fai-da-te” in tutte le direzioni, dal tradizionalismo al progressismo, con una polarizzazione spesso incauta e poco consapevole della delicatezza degli strumenti ermeneutici da adoperare. Basta fare un giro dei vari blog per trovare, accanto a opinioni ponderate, una girandola di estremismi idiosincratici, non fondati su una base di tranquilla solidità dottrinale, o almeno su un poco di umiltà intellettuale e spirituale.
Colpisce soprattutto la sistematica sottovalutazione – da destra e da sinistra – del valore del magistero ordinario per un cattolico.
C’è una singolare concordia tra non pochi tradizionalisti e progressisti nel dire che – salvo il dogma – tutto il resto è disputabile. Ma quest’affermazione andrebbe assoggettata a molte precisazioni. Disputabile da chi? A quali condizioni? Con quali strumenti e con quale grado di pubblicità? Con quali vincoli morali, se poniamo mente al criterio delle Sacre Scritture che pone al primo posto il dovere di non scandalizzare il fratello più debole?
Il Concilio Vaticano II parla chiaro quando dice, per esempio, al n. 25 di “Lumen gentium”, che “questo assenso religioso della volontà e della intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del romano Pontefice, anche quando non parla ‘ex cathedra’. Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato con riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni in conformità al pensiero e in conformità alla volontà di lui manifestatasi che si possono dedurre in particolare dal carattere dei documenti, o dall’insistenza nel proporre una certa dottrina, o dalla maniera di esprimersi”.
Dal canto suo il par. 752 del codice di diritto canonico dispone: “Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell’intelletto e della volontà deve essere prestato alla dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda”.
Ora, è evidente che il cattolico sia moralmente tenuto a prestare l’ossequio religioso – si badi bene – non solo della volontà, ma anche dell’intelletto, a tutta una serie di dottrine non dogmatiche. Il fatto che esse siano eventualmente fatte oggetto di discussione dai teologi – e sempre a certe condizioni ed entro certi limiti – non significa che ciascuno sia abilitato a prescinderne quasi aprioristicamente, in base alle proprie soggettive predilezioni.
Per esempio, chi non ama il culto del Sacro Cuore non è per ciò solo abilitato a disputarne con leggerezza a destra e a manca, ignorando il patrimonio magisteriale in proposito. Lo stesso è da dirsi con riferimento all’ecumenismo o ad altri temi più o meno caldi.
Non intendo qui entrare nel dettaglio dei criteri che regolano la possibilità di un legittimo dibattito su questi temi. Voglio solamente ricordare che detti criteri esistono e sono il frutto di una stratificazione dottrinale consolidata, dalla quale non è possibile prescindere.
Questo vale anche per il Concilio Vaticano II e per una retta ermeneutica della riforma nella continuità. L’appello papale continua a essere sistematicamente disatteso da molti, i quali si rifiutano di applicare questa ermeneutica in concreto.
Per esempio, chi legga bene i primi paragrafi del Catechismo di Pio X e del Compendio di Benedetto XVI troverà affermazioni che non si contraddicono e vedrà che l’aspetto storico-salvifico, maggiormente evidenziato oggi, presuppone quello ontologico e lo integra benissimo.
Lo stesso si può vedere sfogliando il lavoro di teologia fondamentale di Leo Scheffczyk, il quale mostra quali complessi nessi leghino, sul tema della Rivelazione, il Concilio di Trento ai Concili successivi. Parlare – sulla base di estrapolazioni teopolitiche ed ideologiche – di paradigma costantiniano, paradigma tridentino, paradigma storico-salvifico serve fino a un certo punto, perché qui non è in gioco una sistemazione storiografica astratta, ma la vivente continuità nell’identità del deposito della fede.
Una maggiore consapevolezza di questa situazione potrebbe contribuire a far sì che la discussione intraecclesiale – frequentemente rumorosa e sgradevole – possa acquistare il ben diverso timbro della grande polifonia.
Roma, 20 dicembre 2010
Fonte: SETTIMO CIELO di Sandro Magister