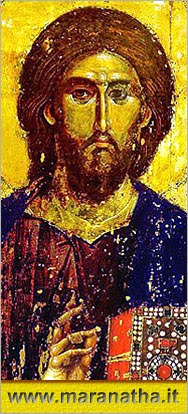di padre Piero Gheddo *
ROMA, venerdì, 30 luglio 2010 (ZENIT.org).- Gli ultimi 50-60 anni della Chiesa cattolica sono di difficile lettura. Per capire questa affermazione, bisogna ricordare lo spartiacque del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965), cioè com’era la Chiesa prima e dopo il grande discrimine. Essendo nato nel 1929 e sacerdote nel 1953, ho vissuto abbastanza per dire che la Chiesa prima del Concilio era molto diversa da quella che viviamo oggi. Certamente più unita e più sicura della Verità che annunziava (lo studio delle teologia a noi giovani seminaristi e preti dava certezze, oggi semina interrogativi, ipotesi e dubbi), ma anche ingessata in formalismi, schematismi, clericalismi, giuridismi, autoritarismi, trionfalismi….
Pio XII, parlando ai giornalisti nell’Anno Santo 1950, aveva esortato a formare una “opinione pubblica” nella Chiesa (il suo discorso era spesso citato alla scuola di giornalismo), cioè la libertà, per formare una coscienza matura, di discutere e anche di dissentire riguardo alla linea tenuta dalle autorità ecclesiali, un dibattito e una condivisione, in modo da non soffocare sul nascere le idee nuove che potevano sorgere anche nei fedeli e nel clero. Ma questa esortazione del Papa era intesa nel quadro della fede e dell’obbedienza sostanziale, per mantenere l’unità e la carità tra i membri del gregge di Cristo.
Poi è venuto l’inaspettato e straordinario Giovanni XXIII (il Papa di Sotto il Monte) e il suo Concilio Vaticano II (1962-1965), una meravigliosa e provvidenziale svolta nella storia della Chiesa dei nostri tempi. In quegli anni lo Spirito soffiava veramente forte e spingeva la Chiesa ad un “aggiornamento”, come diceva Giovanni XXIII. I temi più sentiti alla base e tra i padri conciliari erano la sincerità, la trasparenza, la collegialità, la povertà, la condanna del trionfalismo e del clericalismo, l’apertura al “dialogo” ecumenico e con le religioni non cristiane (la prima enciclica di Paolo VI del 1963 era sul dialogo); insomma, tutti sentivamo l’urgenza per la Chiesa di svecchiarsi e rinnovarsi per essere efficace nel testimoniare e trasmettere il messaggio di Cristo agli uomini del nostro tempo.
Ho seguito a Roma il Concilio come direttore di “Mondo e Missione” (allora era “Le Missioni Cattoliche”) e giornalista dell’Osservatore Romano; inoltre ero “perito”, nominato da Giovanni XXIII, per il decreto “ad Gentes”. Ricordo bene che durante e subito dopo il Concilio noi giovani preti eravamo entusiasti della Chiesa e della missione, avevamo una forte carica di evangelizzazione che ci era venuta proprio dal Concilio. Erano gli anni in cui lo Spirito suscitava numerose vocazioni alla vita consacrata e al sacerdozio.
Ma poco dopo la fine di quel tempo affascinante, nasce nella Chiesa uno spirito di critica, di contestazione, di polemica, che era il frutto dell’atmosfera creata dal “Sessantotto”, un movimento culturale di denunzia, di rivolta contro la società esistente e ogni tipo di “potere” e di “autorità”, che ha creato, assieme a cose positive, anche danni irreparabili alla famiglia (il sesso libero), alla scuola (il voto politico uguale per tutti), alla società (lo spirito di denunzia e di protesta) e alla Chiesa (la contestazione permanente e militante del Papa). Sono solo esemplificazioni sommarie per dire il risultato spesso anarchico del Sessantotto.
Nella Chiesa, soprattutto fra i teologi e la stampa cattolica, si sono formate due correnti di pensiero che, semplificando molto, avevano queste caratteristiche:
1) Da una parte si pensava che il Concilio era finito e andava studiato, vissuto e applicato; dall’altra che il Concilio era un’opera incompleta, incompiuta, cioè rimasta a metà del guado, e che, per aggiornare la Chiesa ai tempi moderni, era necessario proseguire non tanto secondo la lettera (cioè i testi ufficiali approvati), ma secondo “lo spirito del Concilio” sulla via dei dibattiti e delle sperimentazioni, accelerando il cammino verso il prossimo inevitabile Concilio Vaticano III. Si incominciò a discutere fra la lettera e lo spirito del Concilio: la lettera erano i testi dei documenti approvati, lo “spirito” era quello rappresentato dalle idee dei “progressisti” e dei “profeti”. Allora, bastava andare contro quanto il Papa diceva o scriveva (penso ad esempio alla Humanae Vitae del 1968!) e si veniva proclamati “profeta dei tempi nuovi”.
2) Da un lato si guardava al Concilio come alla conclusione di un lungo cammino storico di “aggiornamento” della Chiesa, ma nella continuità col passato; dall’altra il Concilio era inteso come una rivoluzione, una rottura col passato, l’inizio di un cammino nuovo che andava reinventato giorno per giorno; quasi un punto di partenza per una nuova Chiesa, che nel suo passato vedeva solo i fatti negativi.
3) La collegialità nel governo della Chiesa era interpretata in modi molto diversi, direi opposti: da un lato la libertà di esprimere e discutere esperienze e orientamenti nuovi, però nell’obbedienza al Papa e ai vescovi a lui uniti; dall’altro la libertà e l’autonomia delle Chiese locali assumeva un valore assoluto, per cui ogni intervento di Roma era visto (e a volte è ancora visto) come un freno al rinnovamento, un ostacolo all’attuazione dello “spirito del Concilio”. Non solo, ma l’autorità nella Chiesa, in diocesi, seminari e istituti religiosi e missionari, veniva fortemente minata dalla prevalente idea che anche il Popolo di Dio doveva essere governato con metodi “collegiali” e “democratici”. L’autorità infatti, si diceva, viene dal basso, nasce dalla base, dal popolo; mentre secondo la Scrittura e la Tradizione, la Chiesa non è una “repubblica”, ma una “monarchia” perché l’autorità viene da Dio (sto semplificando molto per far capire le conseguenze di un certo spirito di quel tempo!).
4) Il dialogo interreligioso e interculturale era accolto con gioia: ma alcuni lo vedevano come un ascolto, un confronto e una collaborazione con fedeli di altre fedi e credenze, avendo però ben fermo il radicamento nella fede, nella tradizione cristiana e nell’unità della Chiesa; dall’altro era visto come un andare verso gli altri, conoscerne e apprezzarne i “valori”, “fare un cammino insieme”, fino a giungere ad una specie di integrazione vicendevole. La storia di come sono nati e tramontati i “cristiani per il socialismo” (che assurda illusione!) e quelli che promuovevano il dialogo col marxismo e col movimento comunista lo dimostra ampiamente; così come non pochi fra quelli che si erano lanciati nel dialogo (non rettamente inteso) con induismo e buddhismo.
5) Un’altra novità del Concilio era la presa di coscienza della Chiesa circa la fame e miseria estrema di gran parte dell’umanità e delle ingiustizie a livello internazionale fra popoli ricchi e popoli poveri. La soluzione che il Concilio proponeva, oltre alle riforme per orientare come Cristo i credenti verso i poveri e gli “ultimi”, era la “Dottrina sociale della Chiesa” (più volte nominata nella Gaudium et Spes). Ma nell’atmosfera dei tempi post-conciliari e sessantottini, alcuni interpreti “profetici” dello “spirito del Concilio” affermavano che la Chiesa non ha nulla o ben poco da dire in campo politico-sociale-economico. Se si voleva veramente fare il bene dei poveri, bisognava seguire l’unica “lettura scientifica della società” a favore dei poveri, che era quella marxista. Non per diventare comunisti e approvare tutto quello che faceva il comunismo nel mondo, ma per “fare un cammino insieme” alle forze popolari che contestavano il capitalismo e preparavano un mondo nuovo più giusto ed egualitario. “L’unica speranza dei poveri è il socialismo” mi diceva il grande padre Davide Turoldo nel novembre 1973 a Torino, al congresso dei “Cristiani solidali con Vietnam, Laos e Cambogia” (a cui ero stato invitato a dare la mia testimonianza su richiesta del Card. Pellegrino). Non c’è da meravigliarsi perchè allora la cultura dominante in buona parte del mondo cattolico (e anche nelle associazioni giovanili) era questa: oggi nessun cattolico di semplice buon senso lo direbbe più, visto come sono finite le molte esperienze del “socialismo reale”.
6) Nella confusione di idee di quel tempo, che tra l’altro allontanava (o disaffezionava) non pochi preti e fedeli dalla Chiesa, per i vescovi italiani il punto di riferimento preciso era il Papa. Ma l’altra corrente di pensiero affermava che Paolo VI (il “Papa tentenna”, “Paolo il mesto”) era animato dalla “paura del nuovo”. E dopo le aperture del tempo conciliare aveva subito tirato il freno con molti decreti sull’applicazione del Concilio (come la “Ecclesiae Sanctae” del 1966), che ristabilivano l’autorità di Roma sulle Chiese locali, togliendo loro l’autonomia indispensabile per sperimentare e portare avanti le novità conciliari. Paolo VI, a quel tempo, era snobbato, contestato, anche deriso. A volta dico che “il Papa martire” del secolo XX è stato Paolo VI. Alcuni, per salvare la sua persona, dicevano che lui in realtà non era così, ma che la mitica “Curia romana” l’aveva ingabbiato e costretto a fare un cammino diverso da quello che aveva previsto o voluto.
La Chiesa, anche in Italia, oggi soffre ancora di questa divisione, che non viene dal Concilio e dai suoi documenti, ma dall’interpretazione errata che non pochi ne hanno dato. Quindi, mentre in passato, fare il prete era abbastanza semplice anche se costoso in termini di rinunzie, sacrifici e mortificazioni, in seguito è diventato più difficile perché la via da percorrere, per molti, non è più così chiara e sicura.
*Padre Piero Gheddo (http://www.gheddopiero.it/ http://gheddo.missionline.org/), già direttore di Mondo e Missione e di Italia Missionaria, è stato tra i fondatori della Emi (1955), di Mani Tese (1973) e Asia News (1986). Da Missionario ha viaggiato nelle missioni di ogni continente scrivendo oltre 80 libri. Ha diretto a Roma l'Ufficio storico del Pime e postulatore di cause di canonizzazione. Oggi risiede a Milano.