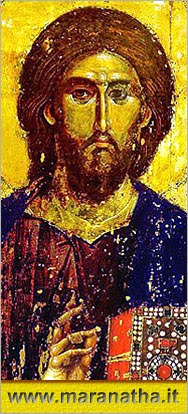Nel volgare di Dante
il segno dei Padri
di Enrico Dal Covolo
L’interpretazione spirituale delle Scritture — alquanto offuscata negli ultimi tre secoli dal metodo storico-critico — torna oggi a essere raccomandata con energia dal magistero della Chiesa, e in particolare da Benedetto XVI, che proprio sulla sostanziale unità dei due Testamenti fonda la proposta di un’esegesi «canonica», o meglio «teologica». Al riguardo, si può vedere ora l’Esortazione apostolica postsinodale Verbum Domini.
Ma prima della rivoluzione illuministica, quando appunto iniziò a prevalere il metodo storico-critico (benemerito, senza dubbio, ma in se stesso insufficiente), non c’era alcun dubbio: di fatto, alla scuola dei grandi Padri, l’interpretazione spirituale e cristologica rappresentò per tutto il medioevo la via privilegiata di accostamento alle Scritture.
Tuttavia questa interpretazione spirituale venne a declinarsi in modi assai vari, come vedremo appunto accostando in primo luogo il metodo della lectio divina, caratteristico dei Padri della Chiesa, e poi la lettura profetico-apocalittica di alcune correnti minoritarie, come i Gioachimiti, a cui la Commedia di Dante Alighieri si ispirò in maniera decisa.
Senza dubbio i Padri accostavano la Scrittura con il metodo della lectio divina. Giacché però su questa gravano ancor oggi pesanti equivoci, non possiamo limitarci a tale semplice risposta. Per uscire dagli equivoci, è necessario illustrare il metodo autentico della lectio. A tale scopo, ci lasceremo guidare dalla stessa dottrina dei Padri.
Dobbiamo riconoscere che il metodo della lectio è più antico dei nostri Padri. Di fatto, esso non è posteriore alla sacra Scrittura, perché lo si rintraccia già all’interno di essa. Valga per tutti l’episodio di Emmaus, alla fine del Vangelo di Luca. Il Signore risorto non è forse egli stesso l’autentico Maestro della lectio divina?
Da parte loro, poi, i Padri greci non si stancarono di coltivare e di raccomandare quella che Origene chiama thèia anàgnosis (la «divina ricognizione» dei testi sacri), e che i Padri latini, a partire da sant’Ambrogio, chiamano lectio divina.
Dopo Ambrogio, il metodo della lectio in occidente rimane legato alle antiche Regole monastiche, finché incontra il suo definitivo «codificatore» in Guigo II, priore della Grande Certosa negli anni fra il 1174 e il 1180. Siamo ormai vicini all’età di Dante.
Guigo ci ha consegnato una presentazione organica della lectio divina nella celebre Lettera «all’amatissimo fratello suo Gervaso», intitolata anche La scala di Giacobbe. «Un giorno, occupato in un lavoro manuale — scrive appunto Guigo II — mi trovai a pensare all’attività spirituale dell’uomo».
Dunque, proprio mentre sta eseguendo un’attività manuale, Guigo si rende conto che ogni manufatto, per riuscire soddisfacente, richiede tempi e ritmi precisi, o — più esattamente — esige una serie di operazioni scalari.
Allora si domanda se per caso non succeda la stessa cosa anche per le attività dello spirito; e prosegue: «Si presentarono improvvisamente alla mia riflessione quattro gradini spirituali, ossia la lettura, la meditazione, la preghiera, la contemplazione. Questa è la scala che si eleva dalla terra al cielo, composta di pochi gradini, e tuttavia di immensa e incredibile altezza, la cui base è poggiata a terra, mentre la cima penetra le nubi, e scruta i segreti del cielo» (Lettera, 2).
Questa riflessione di Guigo ci permette finalmente di elencare, nel loro ordine, le quattro tappe fondamentali, che rappresentano la nervatura della lectio divina: la lectio, la meditatio, l’oratio e la contemplatio.
Aggiungo solo una precisazione, a proposito di quest’ultima tappa, la contemplatio. Non voglio certo negare che — in linea di principio — la parola contemplatio alluda a una forma di preghiera piuttosto elevata. Ma in questo caso i nostri Padri non pensavano tanto alla preghiera (per questo c’era già l’oratio). Pensavano piuttosto al confronto «faccia a faccia» con quel Dio tutto carità, che impone di trasformare in carità la vita intera del credente.
Che cos’è allora la vera contemplatio, nel contesto della lectio divina? È la conversione della vita, e non c’è alcun bisogno di inventare una quinta tappa — che sarebbe l’operatio — proprio perché l’operatio è già di per sé il contenuto autentico della contemplatio.
Conviene ricordare, a questo proposito, un passo della Deus caritas est di Benedetto XVI, là dove il Papa afferma, alludendo chiaramente al pio esercizio della lectio divina: «Nel confronto “faccia a faccia” con quel Dio che è Amore, il monaco avverte l’esigenza impellente di trasformare in servizio del prossimo, oltre che di Dio, tutta la propria vita» (n. 40).
Trascorriamo ora alla lettura profetico-apocalittica delle Scritture e alla Commedia di Dante Alighieri.
Se Dante accolse Roma come nuova mèta del pellegrinaggio di ogni fedele, certamente egli non rinunciò a guardare all’ecumene, alla giustizia e alla pace universali, e dunque agli «stremi» del mondo, a cui si rivolgevano i vecchi pellegrinaggi. Tuttavia — con la sua adesione allo «spirito profetico» (Paradiso, 12, 141) di Gioachino da Fiore, nell’interpretazione che ne offrivano i Francescani spirituali — Dante spostò dalla dimensione «spaziale» a quella «temporale» il suo concetto di universalità, interpretando il Giubileo del 1300 come segno del futuro, luminoso svelamento della verità spirituale.
Questa concezione profetico-apocalittica — che attraversa l’interpretazione gioachimita delle Scritture, come pure l’opera dantesca — ha indotto la critica a correggere la definizione tradizionale della Commedia da «poema allegorico» a «poema figurale».
Come ha dimostrato Auerbach, il modello a cui Dante si attiene non va ricercato né nelle rozze composizioni medievali delle visioni (come quelle di Giacomino da Verona, di Bonvesin da la Riva, di Uguccione da Lodi), né nei poemi allegorici (come il Roman de la Rose), ma nella Bibbia.
Leggendola e interpretandola, Dante — come già i Padri della Chiesa — non lasciava nulla al mondo della fantasia o della finzione, e tutto inverava alla luce del Nuovo Testamento: nei fatti e nei personaggi dell’Antico
Testamento, infatti, egli riconosceva altrettante figure di eventi futuri, carichi sì di più pieni significati, ma che non toglievano alcuna veridicità storica alle figure stesse.
Per spiegare con un esempio la duplice e distinta verità presente nella Commedia, lo stesso Dante nella lettera a Cangrande ricorse proprio alla Bibbia, richiamando l’evento del passaggio del Mar Rosso raccontato nel libro dell’Esodo: se è vero che la liberazione degli Ebrei dalla schiavitù dell’Egitto — realizzatasi con il passaggio del Mar Rosso — prefigura la redenzione, cioè la liberazione definitiva celebrata dalla Pasqua cristiana, non per questo l’adempimento neotestamentario annulla la realtà storica dell’esodo dall’Egitto faraonico, alla quale invece tale adempimento assegna una pregnanza assai maggiore di quella che la moderna concezione scientifica della storia attribuisce ai fatti.
Mentre infatti lo storico moderno considera i fatti storici come una successione continua di accadimenti, senza cercarvi il significato in un disegno complessivo che li inveri, l’interpretazione figurale di Dante suppone la conoscenza dei significati primi e ultimi della storia.
La Bibbia li illumina alla luce di quei «momenti forti» della storia della salvezza (la creazione, l’incarnazione, la redenzione, il giudizio finale), che al continuum degli accadimenti assegnano il loro pieno significato: così attraverso il metodo figurale Dante nella Commedia si assume il ruolo proprio degli agiografi biblici, che avevano scritto la storia umana interpretandola alla luce dei disegni di Dio.
Nella Commedia questo proposito sembra contrastare con lo stesso titolo dell’opera, che allude sia alla «mediocrità» dello stile sia all’«evidenza» del vocabolario adottato dai «viaggiatori-cantastorie» dell’epoca; e invece anche sotto questo profilo la Commedia rivela la propria matrice nell’interpretazione spirituale delle Scritture.
I Padri della Chiesa alla sublimità dei contenuti rivelati dalla Bibbia vedevano giustamente corrispondere quel sermo humilis — che poteva anche scandalizzare alcuni Dottori come Agostino e Girolamo, formati alla nobile retorica classica — ma che rispecchiava la Persona di Cristo, nel quale culmina la rivelazione biblica: umiltà e sublimità si incontrano paradossalmente in Cristo, che è sia l’ultimo degli uomini, sia il figlio di Dio intronizzato alla destra del Padre nel Giudizio escatologico.
L’inesausta dialettica tra lettera e spirito, presente nella Bibbia stessa e rilevata sempre dai suoi più grandi lettori (si pensi ancora una volta a Origene), attraversa l’intero poema di Dante, che da una parte cercava la pantera del Phisiologus al di sotto dei dialetti della penisola, e dall’altra ascoltava docilmente l’ispirazione del «dittatore divino», che attraverso Beatrice lo aveva incaricato di compiere il viaggio narrato nella Commedia.
In questo senso egli aveva inseguito in un primo tempo lo stilus gravis adatto alle canzoni d’amore e al grande tema biblico di Deus caritas, e aveva cercato di avvicinare il suo «volgare aulico» alla lingua che lo stesso Creatore, che è Amore (1 Giovanni, 4, 16), doveva aver ispirato in principio ad Adamo ed Eva, perché «a sua immagine» (Genesi, 1, 27) cantassero il primo epitalamio della storia umana.
Ma questa lingua divina conservata nell’ebraico dei più antichi libri della Bibbia — come il Poeta sosteneva nel De vulgari eloquentia — in realtà non è mai esistita, e dunque anche la lingua delle Scritture doveva essere ricondotta alla storicità e precarietà del linguaggio umano (è quello che Dante negli anni della composizione della Commedia vuole sentirsi dire dallo stesso Adamo, quando lo incontra nel cielo delle Stelle fisse: Paradiso, 26, 91-96).
Eppure, se tale lingua divina non è più materialmente recuperabile dal passato, essa può essere ancora cercata nel futuro, lungo la via spirituale indicata dai gioachimiti: incarnato nella storicità del linguaggio, l’Amore divino può non solo ispirare la vera poesia, ma segnare in senso positivo l’evoluzione storica delle lingue, spingendole ad affratellarsi.
In questo senso Dante può definire le tre lingue sorelle — quella italiana, quella francese e quella provenzale — in contrapposizione amorosa, e quindi divina, con le «rime petrose», adatte invece al «tristo buco sovra ’l qual pontan tutte l’altre rocce» (Inferno, 32, 2-3) del Cocito, nel cui ghiaccio è sequestrato l’Invidioso con il suo carico di odio inestinguibile.
La scelta del volgare fiorentino, concepito come «lingua del sì», trovava dunque giustificazione nelle Sacre Scritture, e Dante poteva servirsene come nuovo Adamo per «ridare nome» ed evidenza a tutte le cose, a quelle del cielo e a quelle della terra, del Paradiso e dell’Inferno.
Si tratta di una novità rivoluzionaria anche all’interno della società cristiana, perché con la scelta del volgare — compiuta attraverso il richiamo alle lingue della Bibbia — Dante toglieva alla casta clericale quel latino che essa aveva adottato come esclusiva lingua del sacro cristiano, e consegnava la locutio vulgaris al popolo laico, in modo che anche gli uomini comuni e le donne potessero esserne partecipi.
Con il volgare neo-latino applicato al sacro cristiano si annuncia quel realismo, che già nell’occidente cristiano — in contrasto con l’oriente bizantino — aveva trovato fioritura nelle arti figurative, dalla miniatura alla pittura, dalla scultura alla sacra rappresentazione, e che ebbe in Giotto, contemporaneo di Dante, l’espressione più alta.
Gli artisti posteriori videro nell’opera di Giotto un’autentica rivoluzione artistica, tanto che, alla fine del Trecento, un suo seguace, Cennino Cennini, scrisse che Giotto «convertì l’arte di greco (bizantino) in latino» (neo-latino).
In tempi recenti si usò rubricare le opere letterarie e figurative, realizzate in questa svolta culminata in Dante e in Giotto, sotto la denominazione complessiva di biblia pauperum per la vasta accoglienza ricevuta in quelle fasce pauperistiche e spirituali del francescanesimo, che Dante frequentò assiduamente.
Ancora una volta, l’interpretazione spirituale delle Scritture presiede al metodo patristico della lectio divina, come al poema figurale di Dante Alighieri.
(©L'Osservatore Romano - 3 febbraio 2011)