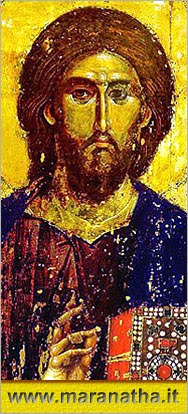I viaggi apostolici nei ricordi di Alberto Gasbarri
Quel baciamano in volo
lungo ventisei anni
di Mario Ponzi
«“Padre Santo, che sei nei cieli...”. Mi viene spontaneo rivolgermi così, nelle mie preghiere, a Papa Wojtyła. “Padre Santo”, perché sin dall’inizio del nostro rapporto di amicizia l’ho chiamato così, con tanta devozione. Mentre “che sei nei cieli” è legato letteralmente al ricordo delle oltre quattromila udienze personali che ha concesso ai membri degli equipaggi degli aerei mentre eravamo in volo verso le mete dei suoi viaggi apostolici. Glieli presentavo uno per uno. Si intratteneva con ciascuno in cordiale colloquio. In quei momenti era più facile comprendere la statura dell’uomo, oltre che del pastore». Schivo e molto riservato, Alberto Gasbarri non ha mai voluto rilasciare interviste. Fa un’eccezione per i lettori del nostro giornale, con i quali condivide alcuni ricordi — «non i più intimi e personali» precisa — dell’esperienza maturata seguendo da vicino Giovanni Paolo II nel suo ministero itinerante per le strade della mondo.
Direttore amministrativo della Radio Vaticana, Gasbarri è soprattutto l’uomo che organizza concretamente il programma dei viaggi del Papa oltre i confini d’Italia. Una delicata missione iniziata nel 1982 come assistente del gesuita Roberto Tucci, ora cardinale, chiamato in quell’anno a sostituire nell’incarico monsignor Paul Marcinkus. Quando infatti il presule statunitense, di origine lituana, passò a un’altra mansione pastorale, la scelta per sostituirlo cadde, anche se provvisoriamente, sull’allora direttore generale della Radio Vaticana e sul suo assistente. Si riteneva infatti che, avendo seguito, per il loro specifico lavoro radiofonico, tutti i viaggi compiuti dal 1978 sino a quel momento, avessero maturato una sufficiente esperienza. Per Gasbarri il «provvisorio» va avanti da trent’anni. Anzi, da quando padre Tucci ha lasciato l’incarico, e dopo un breve periodo di collaborazione con monsignor Renato Boccardo — oggi arcivescovo di Spoleto-Norcia — la responsabilità dei viaggi papali è tutta nelle sue mani. Ha fatto la «gavetta» con Giovanni Paolo II. Di quell’esperienza conserva molti ricordi. Alcuni li racconta in questa intervista.
Il suo è certamente un lavoro atipico, grazie al quale ha avuto l’opportunità di conoscere aspetti di Papa Wojtyła dai più ignorati. Qual è la prima cosa che le è rimasta impressa?
Come uomo, la sua volontà d’acciaio. Come pastore, la forza contagiante della sua preghiera.
Volontà d’acciaio?
Sì. Quando prendeva una decisione era assolutamente irremovibile. È stato difficilissimo, per me, seguirlo in questo atteggiamento. E pensare che ero preparato ad affrontare la difficoltà.
In che senso, scusi?
Nel senso che ero stato messo in guardia da monsignor Marcinkus. Ci trasmise le sue conoscenze su questo lavoro veramente atipico. Ci confidò fin dall’inizio che si trattava di un impegno molto difficile. Bisognava tenere conto di tantissimi dettagli, di tante situazioni da valutare. Insomma era qualcosa di oggettivamente molto complesso. In più si aggiungevano nuovi elementi, a volte imprevedibili. Aveva maturato una certa esperienza organizzando i viaggi di Paolo VI e dunque poteva a ragione valutare la grande differenza con quelli di Giovanni Paolo II. «Ricordatevi sempre — ci disse — che Papa Wojtyła ha una volontà d’acciaio, un carattere e una personalità fortissimi. Quando ha un obiettivo in mente, nessuno lo può fermare. E di questo dovete imparare a tener conto nel preparare i suoi viaggi». Ne facemmo subito esperienza diretta.
Quando?
Non posso dire esattamente quando accadde la prima volta. I momenti sono stati tanti e si sovrappongono nella memoria. Però posso raccontare un episodio che può aiutare a capire quale fosse la sua determinazione. Siamo nel 1992. Nel mese di giugno il Papa aveva compiuto una visita pastorale in Africa. A luglio dovette essere ricoverato per un serio intervento chirurgico. Qualche giorno dopo l’operazione decidemmo, con padre Tucci, di andare al policlinico Gemelli per avere dal suo segretario don Stanislao notizie dirette. Quando ci vide, monsignor Dziwisz insistette per farci entrare nella stanza di degenza. Non volevamo assolutamente disturbarlo. Don Stanislao voleva invece testarne l’umore perché lo vedeva ansioso, inquieto più che sofferente. Era convinto che vedendoci avrebbe pensato subito ai suoi viaggi. Lo trovammo seduto in poltrona. Giusto il tempo di salutare i «due direttori», come ci chiamava affettuosamente; poi, con quell’umorismo che lo contraddistingueva in ogni momento, ci disse: «Ecco, come vedete sono già seduto. Mi manca solo di allacciare la cintura di sicurezza, poi possiamo partire». E non scherzava. Il 14 ottobre eravamo a Santo Domingo per la commemorazione del cinquecentesimo anniversario dell’evangelizzazione. Erano passati poco più di due mesi dalla dimissione dall’ospedale. Si sottopose a un programma massacrante. Tanto che un cardinale del seguito ci rimproverò per questo, soprattutto considerando le condizioni fisiche del Papa. Ma tappe e appuntamenti li decideva lui personalmente. Noi dovevamo solo renderli possibili e organizzarli. Vero è che tanti non riuscivano a stargli dietro, neppure alcuni tra i più giovani al suo seguito. Aveva una forza incredibile.
Esempio indimenticabile della sua «testardaggine» fu quella volta in cui...
Volle sfidare la sua stessa infermità pur di pregare sul Golgota. In occasione del grande Giubileo del 2000, ci chiese infatti di tornare in Terra Santa. Era in condizioni di salute piuttosto critiche e aveva grandi problemi di mobilità, quindi dovemmo tenere in considerazione il suo stato fisico nella preparazione del viaggio. D’accordo con don Stanislao, quando si pensò di fare la visita al Santo Sepolcro, escludemmo che potesse salire sino al Golgota poiché la scala di accesso è talmente stretta e ripida da non consentire l’aiuto a una persona che abbia delle difficoltà. Nelle condizioni del Papa dunque era impossibile. La visita si sviluppò lungo nove densissime e faticose giornate. Al momento di lasciare la residenza del Patriarca latino di Gerusalemme Michel Sabbah — dove il Pontefice era stato ospite prima del congedo — per raggiungere l’aeroporto e partire per Roma, mi accorsi che, nonostante la testa del corteo si fosse mossa, la macchina vhe aveva a bordo Giovanni Paolo II era ferma. Don Stanislao mi chiamò per dirmi che il Papa chiedeva di poter tornare al Santo Sepolcro e di andare a pregare sul Golgota. Per le rigidissime forze di sicurezza israeliane non c’erano dubbi: era impossibile e da escludere assolutamente perché tutte le misure di protezione erano state rimosse, i negozi della città vecchia erano riaperti e i pellegrini avevano già invaso quella parte della città. Dunque non c’erano assolutamente le condizioni per realizzare quel desiderio. Lo spiegai a don Stanislao e al Pontefice. A quel punto Papa Wojtyła prese il braccio del segretario e disse: «Se non vado a pregare sul Golgota, non posso partire da Gerusalemme». Dal suo sguardo capii che non c’erano alternative e mi tornarono alla mente le parole di monsignor Marcinkus: «Quando ha un obiettivo, nessuno lo ferma». Lo feci presente alle autorità competenti. Dovevano scegliere: o avere il Papa fermo in mezzo alla strada per chissà quanto tempo o puntare sulla sorpresa e portarlo al Golgota.
E salì sul colle?
Sino alla cima. Con grande difficoltà raggiungemmo il Santo Sepolcro. Lì ho vissuto un momento che mai dimenticherò. Il Papa non camminava quasi più, si teneva a malapena in piedi e non riusciva a procedere da solo. Lì davanti a quella scala, però, raccolse tutte le sue poche forze residue e si aggrappò ai corrimano. Cominciò a salire lentamente. Lo precedevo camminando all’indietro per controllarlo. Il solerte e fedele comandante della Gendarmeria pontificia, Camillo Cibin, era dietro, pronto a sorreggerlo in caso di difficoltà. Ho visto il volto di Giovanni Paolo II trasfigurarsi per la sofferenza a mano a mano che saliva. Non ebbi la percezione del tempo che impiegammo a salire quei venticinque gradini. Mi sembrò un’eternità. In cima non c’era neanche un inginocchiatoio. Appena giunto crollò in ginocchio sul lastricato per la stanchezza. Era ai piedi dell’altare di marmo del Golgota. Rimase in quella posizione a lungo, assorto nella preghiera. Non dimenticherò mai quell’immagine mai. Anzi, ogni volta che arriva il periodo di Pasqua e penso alla Passione di Cristo, rivedo il volto di Wojtyła mentre sale le scale del Golgota. È stato impressionante. Dopo aver pregato disse: «Adesso possiamo andare».
È vero che a qualunque latitudine si trovasse, il 16 ottobre celebrava la messa di ringraziamento per la sua elezione?
Sì, lo faceva sempre. In genere intorno alle 18. Celebrava la sua messa da solo.
Quando capitò fuori d’Italia?
Lo ricordo bene perché, tra l’altro, fu una evidente testimonianza del suo rapporto con la preghiera. Era il 1991, in Brasile, e credo sia stata l’unica volta in cui nel periodo di un viaggio era compresa la ricorrenza della sua elezione a Pontefice. Ci trovavamo nel Mato Grosso, a Campo Grande, in una piccola missione dei salesiani, dove c’era la residenza del Papa. In quei giorni, come al solito, il programma era massacrante. Anche quella giornata era stata intensissima. Tornammo verso le 18 nella residenza per una breve pausa prima di altri impegni. Don Stanislao chiamò padre Tucci e chiese di preparare subito la cappella perché il Pontefice doveva celebrare. Il nostro disorientamento — o forse la nostra incredulità e preoccupazione per questo ulteriore impegno — spinse don Stanislao a rassicurarci. Sorridendo ci disse: «Il Santo Padre deve celebrare la sua messa». Capimmo e ci unimmo, anche se con la dovuta discrezione, alla sua preghiera.
Come fu possibile fargli accettare le brevi pause che vennero introdotte nel programma dei viaggi per rendere meno gravose le sue fatiche?
Fu difficile e le accettò solo in rarissime occasioni, per una mezza giornata al massimo. Capitò per due volte, in Polonia e in Slovacchia. In Polonia riuscimmo a organizzare una gita in barca sul lago Masuri. Eravamo pochissime persone. Il Papa si lasciò andare ai suoi ricordi: ci raccontò di quando era vescovo e accompagnava gruppi di giovani in quei luoghi per periodi di ritiro spirituale. Mentre parlava, ci indicava i punti precisi sulle sponde del lago dove avevano campeggiato, pregato, trascorso giorni di vacanza. Sul suo volto era visibile la nostalgia per quel tempo passato. In Slovacchia, poi, trascorremmo alcune ore sui monti Tatra, proprio al confine con la Polonia. Anche quella volta ricordò le sue escursioni con i giovani. Anzi, ci raccontò di quando, senza accorgersene, sconfinarono nel territorio cecoslovacco. Alcune guardie di frontiera li fermarono e gli chiesero i documenti con fare minaccioso. Quando lessero il suo nome bisbigliarono qualcosa in slovacco, lingua cheWojtyła conosceva benissimo. «Questo — disse una delle guardie — è il vescovo di Cracovia e mi hanno detto che è meglio lasciarlo stare perché è un tipo difficile».
È vero che non amava passare in rassegna i reparti militari schierati in suo onore quando giungeva in visita nei diversi Paesi?
Per lui era una piccola sofferenza. L’accettava con pazienza. Sapeva che non poteva farne a meno. Ma era piuttosto insofferente. Noi cercavamo di lasciare spazio soprattutto alla gente che accorreva a fargli festa. Era l’unico modo per distrarlo un po’ dalle formalità di quelle cerimonie.
E quando era a tu per tu con i capi di Stato?
Non si è mai fatto problemi, convinto della necessità di dare a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio.
Cosa è rimasto in lei di questa esperienza accanto a Papa Wojtyła?
Intanto la forza sconvolgente e coinvolgente del suo pregare, sempre e comunque. E poi la sua grande umanità e la sua altrettanto grande capacità di ascolto.
In quale circostanza particolare ha potuto percepire questi due aspetti?
Sono stato suo compagno di viaggio per quasi 27 anni in oltre 130 Paesi. Ho volato accanto a lui con 70 compagnie aeree diverse, con ogni tipo di veivolo. I trasferimenti aerei non erano tappe ufficiali della visita e gli equipaggi, dunque, non rientravano nell’elenco delle udienze normali. Tuttavia non c’è stato volo che si sia concluso senza l’incontro con il personale in servizio. Diventò da subito una consuetudine irrinunciabile per il Papa stesso. Ancora oggi continua, perché Benedetto XVI ha voluto mantenerla. Ho fatto un rapido calcolo e sono giunto alla conclusione che si è trattato di una vera e propria «udienza in volo» per circa quattromila persone tra assistenti, piloti, meccanici, dirigenti di compagnie aeree.
Cosa pensava in quei momenti?
Ero quasi sempre in ginocchio davanti a lui, che restava seduto perché l’aereo era in fase di avvicinamento alla pista. Negli occhi aveva sempre quell’espressione di padre affettuoso con tutti. Quel lungo baciamano nei cieli non è mai stato un semplice atto formale. Ognuno gli chiedeva qualcosa o gli rappresentava i suoi problemi: una benedizione per la mamma, per i figli, il conforto per sopportare una malattia da esporre. C’era chi gli offriva un dono, chi gli mostrava un rosario da benedire, un libro da firmare, un Vangelo da siglare. Soprattutto durante gli ultimi viaggi, nel vedere il suo volto affaticato, segnato dalla malattia eppure così aperto al sorriso per tutti, mi veniva spontaneo di pensare alla più bella preghiera insegnataci da Gesù, il Padre Nostro. Pensavo: «Padre Santo, che sei nei cieli». Eravamo abituati a chiamarlo «Padre Santo» in modo affettuoso ma anche rispettoso. E se oggi, alla vigilia della beatificazione, ripenso a quella fila interminabile di persone che lo ha incontrato mentre eravamo in volo, sento riaffiorare sulle labbra quella invocazione: «Padre Santo, che sei nei cieli». E così amo ricordarlo.
(©L'Osservatore Romano 30 aprile 2011)