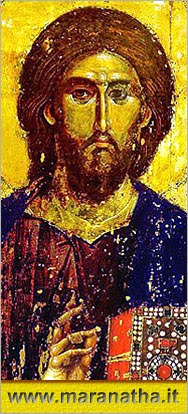11 settembre 2001 - 11 settembre 2011
Dieci anni di asimmetria
di Alain Besançon
Quando mio figlio, quell’11 settembre 2001, mi ha informato di quanto stava accadendo a New York io, incredulo, ho telefonato subito al mio vecchio maestro Marc Raeff, docente alla Columbia University, europeo per formazione. La sua prima reazione è stata: «It’s too much. È una scena da grand-guignol». Intendeva dire: manteniamo il sangue freddo, diamo il giusto peso a questo avvenimento inverosimile, non lo sopravvalutiamo.
Una settimana dopo sono dovuto andare a Chicago per partecipare a un convegno. Ho trovato il Paese paralizzato. C’erano bandiere ovunque, un’orgia di nazionalismo, un clima di mobilitazione patriottica generale, e nello stesso tempo una sorta di panico. La metà degli invitati a quel congresso aveva trovato una scusa: avevano paura di prendere l’aereo. Si può capire l’emozione, o si può criticare questa over reaction.
Sono passati dieci anni. Ground Zero è sempre senza grattacieli. Grandi decisioni sono state prese in nome di tre concetti formulati sul momento e accettati senza un vero dibattito.
Il primo è war against terrorism. Il terrorismo era un fenomeno detestabile, che fino a quel momento aveva portato ad azioni puntuali effettuate dai servizi di polizia, dai servizi d’informazione, da gruppi specializzati ben informati sugli ambienti pericolosi, che operavano con discrezione e in segreto. Evidentemente erano stati tutti sopraffatti da quell’attentato spettacolare destinato a sconvolgere il mondo intero. Ma il concetto di «guerra» non è adatto. Guerra, da sempre, significa una certa simmetria nel conflitto, una certa conoscenza reciproca delle parti coinvolte. Nel caso in questione uno Stato razionale e moderno, sostenuto dalla società che l’ha creato, si trova di fronte a una miriade impalpabile di gruppi non ben definiti, dei quali mal si conosce il legame reale con società che si conoscono ancora meno.
Come chiedeva l’opinione pubblica, e poiché bisognava pur reagire all’11 settembre, gli Stati Uniti sono entrati in due guerre. In Afghanistan e in Iraq hanno fatto l’esperienza che aveva già vissuto la Francia in Algeria, quella in cui la vittoria militare si ottiene tramite un’invasione massiccia e tecnicamente ineccepibile, ma che non porta a nulla. La vittoria — per parafrasare sant’Agostino — è la tranquillità dell’ordine». Si è ben lontani da questo. L’asimmetria risalta fra i soldati superequipaggiati, muniti di armi high tech, e una popolazione enigmatica, indifferente, subdolamente ostile, che li guarda come fossero marziani. E che tuttavia produce combattenti capaci di far esplodere bombe, di terrorizzare con attentati alla cieca, pronti a morire e a suicidarsi.
L’asimmetria non ha fatto altro che aggravarsi in dieci anni. Le nostre società democratiche non sopportano più la morte dei loro soldati, anche se volontari e magnificamente addestrati. La prima guerra mondiale ha fatto morire dieci milioni di giovani. Attualmente, in tutti i Paesi sviluppati la morte in guerra è vista come uno scandalo. Si alza quindi il livello di raffinatezza tecnica, si reclutano milizie mercenarie, i droni sostituiscono i vulnerabili elicotteri. Nello stesso tempo questo genere di conflitti asimmetrici obbliga a compiere azioni sporche che feriscono la coscienza e screditano il nostro rispetto dei diritti dell’uomo. Senza dimenticare che, se dalla nostra parte ci sono pochissimi morti, dall’altra ce ne sono molti, e anche questa è un’asimmetria che colpisce.
Il secondo concetto è implement democracy. È il fine di questa guerra in quanto è ben necessario che una guerra abbia un fine, senza il quale le democrazie non la intraprendono. Che cosa significa, a grandi linee, la democrazia? Un regime rappresentativo sottoposto alla regola del diritto. Un regime, insomma, simile ai nostri. I nostri regimi sono chiamati dagli storici Nuovi Regimi, in contrasto con gli Antichi Regimi sui quali sono stati eretti. Sappiamo che hanno impiegato secoli a costituirsi nel quadro di una civiltà ben precisa, quella dell’Europa, cattolica e protestante, trapiantati poi in America del Nord.
Senza questo fondamento storico «democrazia» è una parola vuota, o piuttosto una maschera che nasconde qualcosa di diverso, a volte il suo contrario. Implement democracy: è possibile laddove il fondamento è quello del mondo orientale o africano? Gli americani citano a volte il caso della Germania nel 1945. Il paragone non tiene. La Germania era una porzione gloriosa della civiltà europea. Dopo l’orrendo episodio nazista, ha ripreso la sua naturale evoluzione e ha accettato ancor meglio la democrazia in quanto la desiderava da un secolo. Lo stesso si può dire della Polonia, che era rimasta europea sotto la glaciazione sovietica. Per capire tutto ciò la political science non basta. Occorre la storia.
Il terzo concetto, nation building, è il prolungamento del secondo. Ma la Nazione è anche una creazione della storia. Un assembramento di clan e di tribù sotto uno Stato creato di sana pianta non è assimilabile a una Nazione. Al suo posto prospera il nazionalismo, che può fare a meno della Nazione, e che significa soprattutto odio verso l’America e i suoi alleati. Non sappiamo ancora se gli sforzi compiuti per dotare l’Africa e il Medio Oriente di Stati nazionali sani e dignitosi porteranno frutti duraturi.
Questi tre concetti hanno determinato un nuovo sistema di alleanze. A causa del primo, e nella prospettiva degli altri due, è stato necessario accettare l’aiuto di alleati democratici solo a parole — che hanno fatto pagare caro il loro appoggio — e sostenere a lungo governi corrotti e dittatoriali ritenuti avversi al terrorismo. Non sappiamo a cosa porterà la loro caduta. È prudente sperare che i nuovi dirigenti, di cui salutiamo la «primavera», abbiano la volontà d’implement democracy, o la capacità di far progredire la nation building?
La terra ha continuato a girare in questi dieci anni, portandoci una marea di nuovi problemi, di nuove sfide che si accumulano senza che quella dell’11 settembre sia stata veramente affrontata. Un esempio: sappiamo meglio cos’è l’islam? Possiamo rispondere a questa domanda fra mille altre: il terrorismo islamico è in rottura con questa religione che si proclama una religione d’amore, di tolleranza e di pace? Assomiglia alla domanda fatta dal Santo Padre nel suo discorso di Ratisbona.
Gli è stato risposto?
© L'Osservatore Romano 11 settembre 2011
Articolo correlato:
Foto aeree degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2011