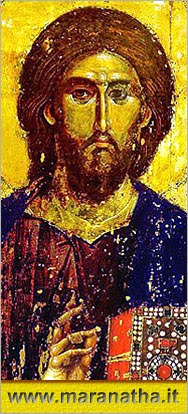L’importanza di riappropriarsi senza intermediazioni
di un’eredità culturale straordinariamente ricca
Perché i preti
devono studiare il latino
Pubblichiamo stralci di una delle relazioni tenute dall’arcivescovo segretario della Congregazione per il Clero nel corso del convegno organizzato dal Pontificium Institutum Altioris Latinitatis alla Pontificia Università Salesiana e dedicato al cinquantesimo anniversario della costituzione apostolica «Veterum sapientia».
di Celso Morga Iruzubieta
La seconda metà del Novecento ha segnato — e non solo a livello ecclesiale — uno spartiacque nella storia dell’uso della lingua latina. Tramontata già da secoli come strumento della comunicazione erudita, ha resistito nella scuola, come materia di studio nei programmi educativi di livello secondario superiore, e, nella Chiesa cattolica, in generale, come mezzo di espressione della liturgia e tramite della trasmissione dei contenuti della fede e di un ampio patrimonio letterario che spazia dalla speculazione teo-filosofica al diritto, dalla mistica e dall’agiografia alla trattatistica sulle arti, alla musica e perfino alle scienze esatte e a quelle naturali.
Con il tempo, tuttavia, almeno sotto il profilo propagandistico, la lingua latina è finita per divenire, in massima parte, appannaggio sempre più caratteristico della formazione clericale nella Chiesa cattolica, al punto di ingenerare una spontanea, quanto forse inappropriata, identificazione tra la Chiesa romana e l’entità linguistica latina, che in essa ha trovato, in questa fase critica, un almeno apparente vigore.
«Apparente» perché, se si considerano a posteriori le circostanze odierne, tutto lascerebbe pensare che la voce del beato Giovanni XXIII, rivolta il 7 settembre 1959 a un convegno di cultori della lingua latina, non sia soltanto rimasta inascoltata, ma che la questione dell’uso e perfino dello stesso insegnamento della lingua latina, anche nel contesto ecclesiale, procedesse, probabilmente, già sui sentieri di un radicale ridimensionamento. «Purtroppo vi sono parecchi che, esageratamente sedotti dallo straordinario progresso delle scienze, hanno la presunzione di rigettare o restringere lo studio del latino e di altre discipline di tal genere».
È fuor di dubbio che l’identificazione tra Chiesa cattolica e lingua latina, in un contesto di secolarismo culturale, e, per un certo tempo, anche di anticlericalismo, dominante — attecchito anche in larghi strati del mondo stesso ecclesiale — abbia prodotto ingenti danni alla sopravvivenza stessa della lingua latina, all’interno dei sistemi educativi, sospinta non tanto dall’accelerazione fulminante del progresso delle scienze “esatte” e delle scienze naturali, quanto da un “intellettualismo critico e sicuro” della propria capacità di sviluppare “impianti culturali autosufficienti”, capaci di prescindere da ogni rapporto di dipendenza da un passato giudicato troppo oneroso e, per di più, caratterizzati dal rifiuto di qualsiasi atteggiamento normativo considerato alla stregua di una forza di coercizione.
Sta di fatto che l’esperienza generale dell’uomo di Chiesa è che il latino sia finito per essere tenuto in maggior considerazione da chi, negli stessi seminari, ma non solo in essi, provenisse da un retroterra formativo, anche assai distante dalla cultura umanistica, piuttosto che da quanti si rivolgevano a interessi di matrice storica, letteraria, teologica, filosofica, spirituale e giuridica (ambito umanistico).
Tuttavia, nonostante le difficoltà, si riscontra oggi tra i sacerdoti la convinzione che scopo dell’avvio al latino sia quello di accostare una civiltà e misurarne valori, interessi e significati, vagliandone insegnamenti e fondamenti teoretici nella prospettiva di una comprensione critica del presente. Si tratta di un segnale decisamente incoraggiante del mondo e della Chiesa contemporanea, disposta a non osservare la lezione e lo studio del passato come un superfluo o retrogrado sguardo inutilmente volto al recupero di qualcosa di tramontato, ma come riappropriazione, diretta e priva di intermediazioni, di un messaggio di straordinaria ricchezza dottrinale, culturale e pedagogica, di una eredità intellettuale troppo vasta, feconda e radicata per lasciare presupporre qualsiasi cesura dalle sue radici.
Allo stato attuale, appare improbabile che si riesca a far apprezzare al sacerdote, ancor meno nella fase iniziale del proprio percorso formativo, il valore del latino come lingua dotata di nobiltà di struttura e di lessico, capace di promuovere uno stile conciso, ricco, armonioso, pieno di maestà e di dignità, che giova alla chiarezza e alla gravità, atta a promuovere ogni forma di cultura, l’humanitatis cultus, tra i popoli.
È in questo recupero di un’identità culturale propria, in questa ripresa dal fondo delle motivazioni della presenza stessa della Chiesa nella società che si configura l’importanza del latino nel curriculum scolastico degli aspiranti al sacerdozio, riscattandola da ogni semplicistico — nonché scorretto e riduttivo — quesito sulla sua funzionalità pratica e riabilitandone il ruolo di materia ampiamente formativa.
È in tale prospettiva che Paolo VI, nel motu proprio Studia latinitatis — con cui istituiva presso l’allora Ateneo Salesiano il Pontificio Istituto Superiore di Latinità — ribadiva con decisione nell’esordio stesso del testo lo stretto legame tra lo studio della lingua latina e la formazione al sacerdozio, riaffermando il carattere di ineluttabilità di una non exigua scientia del latino. «È stata in ogni epoca convinzione dei Sommi Pontefici che lo studio della lingua latina e della letteratura antica sia assolutamente congiunto con l’istruzione e la formazione dei seminaristi e, in passato come ai nostri giorni, essi hanno pubblicato su tale argomento importanti documenti».
Un primo aspetto della sua utilità, intrinsecamente legato alla formazione del sacerdote, è nel suo disporsi come tramite di un insieme di valori che favorisce il pieno sviluppo della personalità, delle disposizioni dell’animo e di un’autentica maturità umana che si ripercuote nella capacità di operare scelte ponderate e di giudicare con retto spirito critico uomini ed eventi, nell’acquisizione del dominio di sé, nello sviluppo dello spirito di iniziativa, nella capacità di lavorare in comune con i confratelli e con i laici, nella cura di valori quali la lealtà, il rispetto, la giustizia, la fedeltà, la gentilezza del tratto, la discrezione, la carità, il retto uso della libertà.
Veicolo di una visione antropocentrica del mondo profondamente intrisa di spiritualità cristiana, la lingua latina consente di offrire un contributo autorevole e peculiare nel valutare e orientare gli obiettivi emergenti dalle nuove scienze, riconfigurando ogni nozione di progresso in un equilibrato bilanciamento tra ricerca di felicità e benessere e risposta alle esigenze profonde dell’homo interior.
Questa formazione culturale, radice nonché patrimonio bimillenario della pedagogia e della cultura ecclesiastica costituisce il tramite collaudato di un discernimento sapiente nel dialogo tra fede e ragione, nel discernimento dei valori mutuabili nel contatto con diverse o nuove forme di cultura, nella costruzione di personalità che si distinguano per essere simul pastoralia et theologica, catechetica et culturalia, spiritalia et socialia praecellentem in modum.
Ma la conoscenza delle lingue classiche è tanto più necessaria per il sacerdote nel suo compito di educatore del popolo e formatore della comunità nella maturità della fede mediante la pratica di una carità sincera e attiva, l’esempio, la preghiera, l’esercizio di quella libertà con cui Cristo stesso ha reso l’umanità libera, rendendolo «strumento efficace per indicare o agevolare a chi ancora non crede il cammino che porta a Cristo e alla sua Chiesa e per stimolare, alimentare e sostenere anche i credenti nella lotta spirituale».
Tale ruolo passa inevitabilmente attraverso una riappropriazione di quel mondo di valori che definisce il cristianesimo in un legame di continuità che fa del presente il frutto di una millenaria elaborazione. Recidere il legame e stabilire uno iato con il passato significa, infatti, per il mondo sacerdotale un impoverimento radicale, nella stessa misura in cui la mancanza di memoria rappresenta, dal punto di vista medico, uno stato patologico e non la normalità dell’individuo.
Questa continuità costituisce un legame che connette la Chiesa, la cultura cristiana e il sacerdote odierni con le proprie radici in un rapporto diretto di dipendenza in cui si attingono stimoli e suggestioni che definiscono la propria autentica identità, non come modelli idealizzati, perduti e inarrivabili, ma come un archetipo di una tradizione in continua evoluzione, ben lungi dall’essersi esaurita.
Studiare il latino significa accostare direttamente, senza mediazioni linguistiche e, per ciò stesso, culturali, autori come Agostino, Cipriano, Leone Magno, Isidoro di Siviglia, Alcuino, Bernardo, Ildegarda di Bingen, Tommaso, Bartolo da Sassoferrato, ma anche Lucrezio, Virgilio, Seneca, Boezio, Ulpiano, Graziano, al pari di tanti altri maestri delle arti e del pensiero, che in qualche misura hanno orientato e continuano a orientare il modo di essere e di esprimersi odierno.
Solo attraverso il latino il sacerdote apprende come fondamento della propria formazione quella consuetudine con il Deus caritas e fa del praevenire amando agostiniano, l’arrivare per primi nell’amare, la colonna portante di quell’intero sistema pedagogico che è l’apostolato.
© L'Osservatore Romano 25 febbraio 2012