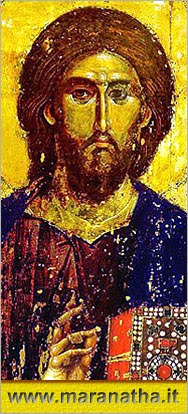Di fronte al mistero della sofferenza e della morte
Castigo e misericordia
Anche nelle catastrofi naturali l’umanità mai è priva della vicinanza di Gesù
di Inos Biffi
Senza la fede cristiana il problema del male, cioè della sofferenza nella varietà delle sue forme, resta un insolubile enigma. Se poi lo si fa risalire a un’anonima volontà malvagia o a un destino che opera crudelmente e ineluttabilmente nel mondo, l’enigma si infittisce e l’uomo appare inspiegabilmente in balìa a un’implacabile forza perversa, che si abbatte su di lui, di là dalla sua stessa colpevolezza. Soprattutto dall’esperienza di questa «ingiustizia» e fatalità del dolore sono nati, tra gli altri, i capolavori della letteratura — pensiamo alla tragedia greca — che hanno interpretato, con i loro lamenti, i loro affanni, i loro silenzi, la drammatica condizione umana di ogni tempo.
La ragione non è in grado di trovare una soluzione, che spieghi o giustifichi il dolore; in ogni caso le possibilità dell’uomo appaiono impotenti a trovarvi un rimedio duraturo e veramente efficace, soprattutto quando con la morte — la «fatal quiete» — sopraggiunge il suo definitivo e irreversibile suggello.
Per chi non ha la fede ogni discorso sulle tribolazioni e sui patimenti che affliggono l’umanità in generale, e ogni uomo in particolare, risulta non solo arduo e oscuro ma alla fine affatto inidoneo a proporre soluzioni persuasive, impotente a placare l’inquietudine, a rassicurare e a suscitare speranza.
Chi ha fede dev’esserne consapevole, per non diventare — come direbbe Giobbe — un «consolatore molesto», un elegante compositore di parole (cfr. Giobbe, 16, 2-4) che hanno come esito quello di accrescere il tormento e l’oppressione. La presenza cristiana si manifesta anzitutto in un ascolto silenzioso, pieno di delicatezza e di discrezione, che sa specialmente trasformarsi nell’offerta attenta e sollecita di un aiuto che rechi concreto sollievo.
D’altra parte, l’annunzio del Vangelo e il sopravvenire della grazia non rimuovono dal mondo la sofferenza. Essa permane con la sua «ingiustizia» e il suo strazio. E, tuttavia, la rivelazione ne illustra anzitutto la genesi. La sofferenza entra nel mondo a motivo del peccato commesso all’origine. Lo afferma san Paolo: «A causa di un solo uomo è entrato nel mondo il peccato e, con il peccato, la morte» (Romani, 5, 12). Una morte che suggella il peccato ed è il simbolo reale e quindi la consumazione di tutti i mali e di tutti i dolori.
Dio, per definizione immensamente buono, non ha dunque creato il male. E neppure esso è dovuto a un Principio, quasi una divinità prepotente e malefica, che lo abbia disseminato nel mondo. La causa risale alla ribellione di Adamo. E questa è una verità di fede cattolica.
E a proposito di verità di fede cattolica forse è il caso di ricordare alcune cose. In primo luogo, che possono appartenere alla fede cattolica anche verità non definite.
Inoltre, quanto è veramente di fede non può e non deve essere attenuato o proporzionato alla diversa sensibilità e accettabilità delle persone, ma va proclamato con limpidità nei suoi termini esatti e sicuri, quand’anche susciti reazioni e rigetto. Così, riguardo al peccato originale: senza dubbio le sue diverse spiegazioni teologiche sono aperte alla libera discussione per cui possono variare nell’interpretazione e nell’espressione, però a una condizione imprescindibile, che venga in ogni caso proclamata la verità cattolica, la cui accoglienza esige la fede.
Infine, una terza osservazione: oggi va quasi di moda citare l’esortazione della Prima Lettera di Pietro: «Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere — “tuttavia con dolcezza e rispetto” – a chiunque domandi ragione della speranza che è in voi» (3, 15). Se, esulando dal preciso contesto della Lettera, intendiamo il «dare ragione della speranza» come l’esporre le motivazioni che giustificano la professione cristiana, è chiaro che tali motivazioni si fondano e non cesseranno mai di fondarsi sulla Parola di Dio e quindi sulla fede. Esse verranno esposte senza arroganza e senza disprezzo o disattenzione nei confronti di chi non crede, ma non per questo si enunceranno in maniera timida e titubante. Così, lo si farà pure nel modo più gentile e positivo possibile, ma anche di fronte a chi dovesse scandalizzarsi e ribellarsi si affermerà che, per quanti muoiono nell’ostinata ribellione a Dio, esiste una dannazione eterna.
Se ora torniamo al nostro tema, troviamo che il Catechismo della Chiesa cattolica anzitutto dichiara che il peccato originale fu da noi «contratto» ma non «commesso»; che è «condizione di nascita e non atto personale»; e che la sua «trasmissione rimane un mistero che non possiamo comprendere appieno» (n. 76). Detto questo, il Catechismo prosegue affermando che, «in conseguenza del peccato originale», «la natura umana è sottoposta all’ignoranza, alla sofferenza, al potere della morte» (cfr. nn. 76-77). È una verità cattolica, che riflette il pensiero di Paolo, sopra accennato.
Possiamo allora concludere: la sofferenza come «castigo» divino per il peccato originale? Intanto viene da chiederci che cosa possa significare l’espressione: «Dio “castiga”», sapendo che nei confronti di Dio il nostro è sempre un linguaggio analogico, necessariamente attinto e mediato dalla modalità creaturale. Come scrive Tommaso d’Aquino: «Nessun nome è predicato in modo univoco di Dio e delle creature» (Summa Theologiae, I, 13, 5, c). Ma, più ancora, si affaccia l’interrogativo: che senso può avere un «castigo» inflitto ai discendenti di Adamo per un peccato inevitabilmente «contratto», però non «commesso», «condizione di nascita», ma «non atto personale»? E sarebbe, non dico gentile e rispettoso, ma veramente sensato asserire, per esempio, che un popolo è colpito da una catastrofe a motivo del peccato originale, cioè per una ragione che esula totalmente da una propria responsabilità? Se la motivazione è la colpa di Adamo, essa si dovrebbe abbattere su tutta l’umanità, non solo su una sua porzione.
La verità è un’altra, ossia che il genere umano non fu mai lasciato sprovvisto della grazia della redenzione; che esso non si trovò mai in un puro stato di «castigo» per il peccato originale, e quindi in uno stato di natura decaduta irredenta, che qualche illuminato teologo giustamente ritiene impensabile.
La discussione è teorica e in ogni caso arriva in ritardo. Qui a contare non sono le ipotesi, ma la scelta divina, secondo la quale l’uomo, creato dalla misericordia, è stato misteriosamente dall’eternità progettato e voluto, come — direbbe sant’Ambrogio — «liberto di Cristo» (De Iacob et vita beata 1, 3, 13). Ma nella sua fulgente chiarezza soprattutto la Lettera di Pietro parla del «sangue prezioso di Cristo», «Agnello senza difetti e senza macchia», «predestinato già prima della fondazione del mondo» (1, 19-20). L’umanità non è mai esistita da sola, cioè priva della «solidarietà» di Gesù Redentore; senza la grazia del suo sacrificio e del suo perdono. Ogni tipo di sofferenza è alla fine destinato nel piano di Dio a essere una comunione con la passione del Signore, il Giusto immolato: si tratti della sofferenza entrata nel mondo col peccato dei progenitori e sopravvenuta come strascico in tutto il genere umano, o di quella originata da proprie mancanze deplorate nel pentimento, o, particolarmente, della sofferenza incolpevole — richiamiamo la figura di Abele, preannuncio della vittima innocente del Calvario. Il pensiero va alle parole di Manzoni a conclusione de I promessi sposi: «I guai (…) quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore», e a quelle pronunziate da fra Cristoforo dinanzi a don Rodrigo morente di peste al Lazzaretto: «Può esser gastigo, può esser misericordia»; noi potremmo parlare di castigo che è divenuto misericordia.
Il dolore umano è da sempre arcanamente connesso con i dolori del Crocifisso; da sempre in ogni uomo che patisce si riflette il Cristo, così come ogni grazia di salvezza, in qualsiasi tempo della storia, è un’impronta della grazia di Gesù salvatore. Né importa che se ne abbia un’esplicita consapevolezza.
Il dolore come puro castigo, deputato a compensare e a equiparare in certo modo la colpa, non è mai esistito e non è neppure pensabile. Dal principio Dio levò alla tribolazione dell’uomo sia il carattere oscuro dell’assurda fatalità e dell’incidente irragionevole, sia quello della finalità afflittiva, capace di placare la sua ira. Una tale persuasione rivelerebbe una concezione pagana di Dio e dei suoi sentimenti.
Gesù Cristo ha poi contestato radicalmente la mentalità che collegava afflizione e colpa personale, rimandando, invece, la traversìa a un disegno divino. Disse a proposito del cieco nato: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio» (Giovanni, 9, 3).
Solo la pena del dannato non può più essere redentiva; e non perché Dio ha cessato di amarlo e si compiace di castigarlo e di torturarlo: quel castigo, in realtà, è il riflesso della fissazione ostinata del dannato stesso nell’avversione a Dio e quindi nel male.
A questo punto appare chiaro che quello che abbiamo fatto è un discorso di fede. Se non che la fede non dissipa ogni oscurità, lascia l’ansia della visione, o, come afferma Tommaso d’Aquino, «non ne acquieta il desiderio» (Summa contra Gentiles, III, 40, 4). In particolare, ignoriamo perché Dio abbia voluto un mondo dove ci fosse, per colpa dell’uomo, la dimensione del peccato; perché, come scriveva Pietro, troviamo l’Agnello con il suo sangue «predestinato già prima della fondazione del mondo».
Comunque, unicamente per fede siamo certi che «le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi» (Romani, 8, 18) e che nelle sofferenze portiamo a termine ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella nostra carne (cfr. Colossesi, 1, 24).
Il discorso sul dolore resta precario e suscettibile di fraintendimento, quando non venga compreso nel mistero del disegno di Dio: ma anche allora quanta delicatezza richiede quando si tratta del dolore degli altri! Che, se ci si ritrova a parlarne con chi ne è afflitto e non è credente, la più persuasiva parola è la fraternità delle opere di misericordia, e l’impegno rinnovato a diffondere il Vangelo.
(©L'Osservatore Romano 14 maggio 2011)