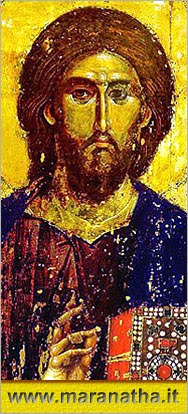[...] Ma abbiamo almeno altri due motivi circostanziati per i quali esprimere al Papa la nostra gratitudine: il primo riguarda l’istruzione Universae Ecclesiae volta a dare una corretta applicazione del «motu proprio» Summorum Pontificum del 7 luglio 2007, e dunque al recupero più impegnativo e armonioso nell’ambito delle singole Diocesi dell’intero patrimonio liturgico della Chiesa universale. In sostanza, a non ferire mai la concordia di ogni Chiesa particolare con la Chiesa universale, operando piuttosto per unire tutte le forze e restituire alla liturgia il suo possente incanto.
Nella prolusione all’assemblea della Conferenza episcopale
La lezione di Giovanni Paolo II
per il futuro dell’Italia
di Angelo Bagnasco
Cardinale, Presidente Conferenza Episcopale Italiana
di Angelo Bagnasco
Cardinale, Presidente Conferenza Episcopale Italiana
Si è aperta oggi nella sala del Sinodo dei Vescovi, nella Città del Vaticano, la sessantatreesima assemblea della Conferenza episcopale italiana (Cei), che si concluderà il 27 maggio. Pubblichiamo ampi stralci della prolusione del cardinale presidente.
Il nostro sguardo è ancora pervaso dalla beatificazione di Giovanni Paolo II, con gli eventi ad essa connessi. In un tempo facilmente catturabile dall’apparenza e dall’effimero, si è assistito all’esaltazione di un autentico uomo di Dio, la cui santità è stata riconosciuta col dovuto rigore dall’autorità della Chiesa, la quale ha così intercettato un consenso sorprendente, più ampio dei confini cattolici.
Noi vescovi guardiamo a Giovanni Paolo II con particolare attenzione e responsabilità: egli, infatti, ha accettato il pontificato ma non ha chiesto di scendere dalla croce. Vivendo l’esistenza a lui destinata, si è rivelato testimone credibile ed è stato ascoltato. Quello che diciamo a noi stessi, dobbiamo chiederlo anche ai nostri amati Sacerdoti, ognuno fidandosi di Gesù, e gettando continuamente la rete affidati alla sua parola. Nell’essere preti non c’è un potere da esercitare ma un’obbedienza secondo cui agire, contrastando la sonnolenza che prende i discepoli lungo la storia (cfr. Benedetto XVI, Udienza generale, 20 aprile 2011).
Precisamente così Giovanni Paolo II si è comportato, cesellando la propria vita secondo la forma pasquale, e dimostrando a tutti che cosa può diventare l’esistenza di una persona quando si lascia afferrare da Cristo. Il rapporto con Dio è infatti l’elemento generativo di una personalità formidabile e fascinosa. La santità, per lui, fu obiettivo precedente ogni altro, l’opzione su cui ha innestato e orientato le altre scelte, a cominciare da quella sacerdotale; l’opzione che ha perseguito senza esitazioni e vischiosità, senza il timore che Dio gli chiedesse troppo, dispiegando al contrario un’interpretazione piena della chiamata alla vita.
Tutti ricordiamo, non senza emozione, il legame spirituale intenso e amico che correva, benefico per la Chiesa intera, tra Giovanni Paolo II e colui che nel disegno della Provvidenza – sarebbe stato il suo successore. All’indomani dell’elezione, Benedetto XVI disse davanti al collegio cardinalizio ancora riunito nella Cappella Sistina: «Mi sembra di sentire la mano forte di Giovanni Paolo II che stringe la mia, mi sembra di vedere i suoi occhi sorridenti e di ascoltare le sue parole, rivolte in questo momento particolarmente a me: “Non avere paura”» (Omelia ai Cardinali elettori, 20 aprile 2005). E il 1° maggio è andato oltre, come se la distanza temporale, anziché attenuare i sentimenti, li avesse rinforzati. Ha commosso infatti il suo inchinarsi quasi a fondersi con il popolo cristiano, lui cui è toccato in sorte d’essere a sua volta Pietro quando ha concluso, con la spontaneità del cuore: «Santo Padre, ci benedica». Qualcosa di più della semplice continuità: c’è una perdurante ammirazione spirituale che diventa stupefacente lezione di stile, di umiltà e di candore, dalla quale noi sentiamo di dover imparare. Da una voce attendibile è stato osservato che Papa Ratzinger «si è presentato al mondo come il primo devoto del suo Predecessore» (Monsignor Georg Gänswein, Intervento al Premio Capri, in “Avvenire” del 26 settembre 2010), giacché tale interiormente egli si sente. E l’hanno, appunto, avvertito tutti. Anche noi allora, in punta di piedi, diciamo a Benedetto XVI la nostra spirituale ammirazione, rinnovandogli il grazie più sentito per la beatificazione, espresso già con il comunicato del 29 aprile scorso.
Ma abbiamo almeno altri due motivi circostanziati per i quali esprimere al Papa la nostra gratitudine: il primo riguarda l’istruzione Universae Ecclesiae volta a dare una corretta applicazione del «motu proprio» Summorum Pontificum del 7 luglio 2007, e dunque al recupero più impegnativo e armonioso nell’ambito delle singole Diocesi dell’intero patrimonio liturgico della Chiesa universale. In sostanza, a non ferire mai la concordia di ogni Chiesa particolare con la Chiesa universale, operando piuttosto per unire tutte le forze e restituire alla liturgia il suo possente incanto. La seconda circostanza è data dalla «lettera circolare», inviata ad ogni vescovo dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, in vista della preparazione di necessarie «linee guida» per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori. Si tratta di contestualizzare nei diversi Paesi, da parte delle rispettive Conferenze episcopali, le norme emanate il 21 maggio 2010 per aggiornare il «motu proprio» papale Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 aprile 2001. Ebbene, confermando che «la responsabilità nel trattare i delitti di abuso appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano», si dovrà arrivare, avverte la lettera, entro il mese di maggio 2012 «ad un orientamento comune all’interno di ogni Conferenza Episcopale nazionale, aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori». A tale riguardo, riconoscendo su questo fronte un’infame emergenza non ancora superata, la quale causa danni incalcolabili a giovani vite e alle loro famiglie cui non cessiamo di presentare il nostro dolore e la nostra incondizionata solidarietà, vorrei anche assicurare che da oltre un anno, su mandato della presidenza Cei, è al lavoro un gruppo interdisciplinare di esperti proprio con l’obiettivo di «tradurre» per il nostro Paese le indicazioni provenienti dalla Congregazione; obiettivo che sotto il nome di «Linee guida» oggi viene autorevolmente richiesto a tutte le Conferenze episcopali del mondo. L’esito di tale lavoro sarà presto portato all’esame dei nostri organismi statutari. Ripetiamo però quest’oggi il grido amaro che già è risuonato nell’assemblea dello scorso anno: sull’integrità dei nostri sacerdoti non possiamo transigere, costi quel che costi. Anche un solo caso, in tale ambito, sarebbe troppo. Quando poi i casi si ripetono, lo strazio è indicibile e l’umiliazione totale (cfr. Prolusione all’Assemblea generale dell’Episcopato italiano, 24 maggio 2010). Ma le ombre, anche le più gravi e dolorose, non possono oscurare il bene che c’è. Ancora una volta, quindi, noi Vescovi confermiamo stima e gratitudine al nostro clero che si prodiga con fedeltà, sacrificio e gioia, nella cura delle comunità cristiane.
Che cosa resta della larghissima partecipazione registrata il 1° maggio scorso? Senza indulgere a letture enfatiche, basta ricordare i gesti compiuti dai tantissimi che hanno avvertito il bisogno di rendersi presenti, a Roma, per l’evento. Neanche stavolta è mancata sui media la domanda ricorrente in questi casi: ne valeva la pena? La risposta che in generale danno i diretti protagonisti è senza esitazione: sì, ne valeva la pena. Desideriamo solamente segnalare come, nel passaggio da una religione d’abitudine a una fede personale, questo genere di esperienze lascino una traccia. È il coinvolgimento soggettivo ad essere decisivo, è la valorizzazione della propria singolarità a fare la differenza. Certo, occorre guadagnare un rapporto esplicito e consapevole con l’alterità che è Cristo e lasciarlo parlare. Giovanni Paolo II è stato il suggeritore illuminato di una consapevolezza che è bene non manchi nelle nostre comunità: la trasmissione della fede passa per l’ancoraggio a ciò che vi è di profondo e soggettivo. Nella Chiesa, rami un tempo rigogliosi possono rinsecchire, ma spunta una gemma, si affaccia un uomo il cui volto esprime una profonda fede in Dio, la storia si riaccende, i suoi cardini si smuovono, e tutto ricomincia.
Il 17 aprile scorso, domenica delle Palme, ha avuto luogo nelle Chiese particolari la fase locale della Giornata mondiale della Gioventù, cui il Papa quest’anno ha affidato il tema «Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede». L’evento avrà il suo secondo tempo in estate, a Madrid, dove dal 16 al 21 agosto si svolgerà il XXVI raduno mondiale. I nostri giovani sono dunque in cammino. Auguriamo loro di vivere con impegno l’ultimo periodo dell’anno scolastico, ricavando da tale esperienza tutto ciò che si può trarre per la propria crescita intellettuale e culturale. La scuola non è un parcheggio, non è neppure il tempo che intercorre tra una vacanza e l’altra. Neanche basta dire che la scuola è per la vita: essa, la scuola, è già vita. C’è troppa banalità oggi attorno all’asse primordiale della civiltà, qual è l’amare, il generare o non generare figli, l’educarli che vuol dire rigenerarli un’altra volta, ma per un tempo enormemente più lungo.
Giovedì prossimo, nel tardo pomeriggio, ci recheremo nella basilica di Santa Maria Maggiore e, alla presenza del Papa, nostro Primate, pregheremo per l’Italia nel 150° anniversario dell’Unità nazionale. Si completerà così il gesto del 17 marzo scorso, quando con una solenne Concelebrazione Eucaristica alla presenza delle massime Autorità dello Stato abbiamo ringraziato Iddio per il nostro Paese e il nostro popolo. Sappiamo che, nell’attaccamento alla Madre del Redentore e nostra, c’è un dato storico che da sempre ci unisce, e che in tale devozione si rintraccia il volto popolare della nostra terra. In una fase cruciale della giovane storia unitaria di questa antica nazione, Giovanni Paolo II ha dato un contributo, culturalmente documentato e al contempo scevro da condizionamenti psicologici e biografici, veramente determinante per il recupero della stima che gli italiani devono avere di se stessi e del proprio compito rispetto agli altri popoli e alle altre nazioni, e in solidarietà con questi. Se, nonostante tutto, il Paese regge è perché ci sono arcate, magari non immediatamente percepibili, che lo tengono in piedi. La rappresentazione pubblica talora soffre di qualche unilateralità e di predominanze che nei fatti non trovano sempre giustificazione. L’Italia non è solo certa vita pubblica. Ovvio che non si debba cadere in schemi manichei, in generalizzazioni ingiuste e inaccettabili. Se oggi diciamo che vi è una rappresentazione della vita politica svincolata dalle aspirazioni generali, lo facciamo certo con l’avvertenza dei meccanismi sofisticati che fatalmente concorrono alla proiezione esteriore delle società moderne. Eppure non ci sono scusanti. La politica che ha oggi visibilità è, non raramente, inguardabile, ridotta a litigio perenne, come una recita scontata e — se si può dire — noiosa. È il dramma del vaniloquio, dentro, come siamo, alla spirale dell’invettiva che non prevede assunzioni di responsabilità. La gente è stanca di vivere nella rissa e si sta disamorando sempre di più. A potenziale contrasto, c’è una stampa che appare da una parte troppo fusa con la politica, tesa per lo più ad eccitare le rispettive tifoserie, e dall’altra troppo antagonista, e in altro modo eccitante al disfattismo, mentre dovrebbe essere fondamentalmente altro: cioè informazione non scevra da cultura, resoconto scrupoloso, vigilanza critica, non estranea ad acribia ed equilibrio. Ma segnaliamo lo iato anche per dare voce all’invocazione interiore del Paese sano che è distribuito all’interno di ogni schieramento. In quanto vescovi, non ci stanchiamo di incoraggiare i gesti di assennatezza che mirano a creare condizioni di pace sociale e di alacre operosità. Se non parliamo ad ogni piè sospinto, non è perché siamo assenti, anzi, ma perché le cose che contano spesso sono già state dette, e ripeterle in taluni casi non serve. Si sappia tuttavia che la nostra opzione di fondo, anche per il conforto dei ripetuti appelli del Papa (per l’ultimo, in ordine di tempo, cfr. Discorso all’assemblea del 2° Convegno ecclesiale triveneto, Aquileia, 7 maggio 2011) resta quella di preparare una generazione nuova di cittadini che abbiano la freschezza e l’entusiasmo di votarsi al bene comune, quale criterio di ogni pratica collettiva. Affinché l’Italia goda di una nuova generazione di politici cattolici, la Chiesa si sta impegnando a formare aree giovanili non estranee alla dimensione ideale ed etica, per essere presenza morale non condizionabile.
Desidero per un istante riprendere il filo di un discorso già abbozzato in precedenti circostanze e che riguarda quella patologia del post-moderno che va sotto il titolo di un individualismo indiscriminato. L’individualismo non può coincidere con l’«indifferenza», con l’apatia sociale, con il narcisismo incurante degli altri e del mondo. In questo, si vorrebbe davvero che le donne e gli uomini di cultura fossero anche illuminati nel saper cogliere in tempo i rapporti di consequenzialità tra le istanze da raccordare e i fenomeni che, pur volendolo, sarà poi impossibile evitare. C’è chi si ostina a rappresentare la Chiesa come un soggetto che si batte contro la modernità. Vorremmo appena ricordare che la modernità trova radici e, in fondo ha la sua migliore garanzia, nel Vangelo: la dignità incomprimibile della persona, l’uguaglianza fra tutti in quanto figli di Dio, la libertà che Cristo più di ogni altro rispetta, offrendo il suo amore salvifico e rigeneratore... sono le consapevolezze scaturenti da quelle pagine, da duemila anni germinatrici di testimonianze eloquenti. Più che avversaria della modernità, la Chiesa a guardare bene ne è l’anima. Si potrebbe dire che, con gelosia, ne custodisce gli ingredienti di base.
C’è anche chi, partendo da una ricognizione dei più recenti rivolgimenti in atto nel Nordafrica, riesce a scorgervi non solo la fine di ogni vera influenza occidentale, ma anche la prova che l’ordinamento assoluto messo in campo dalle religioni, compresa quella cristiana, si sta sgretolando, se già non è ormai abbattuto. Onestamente, non si riesce a comprendere tale demolitoria lena nei confronti delle religioni, e di quella cristiana in particolare, e di conseguenza la corsa a frantumare qualunque premessa di alleanza virtuosa nel nostro Paese tra il cattolicesimo e l’umanesimo laico, come invece sarebbe decisamente da propiziare appena si voglia costruire. Noi crediamo che l’aver messo da parte ciò che ha in sé lo statuto epistemologico dell’assoluto non sia fino ad oggi servito a dare plausibile spessore morale ad una società inquieta e convulsa.
Per questa consapevolezza, noi vescovi non esitiamo ad esplicitare l’auspicio che avvertiamo urgente in merito a talune questioni poste all’ordine del giorno del dibattito pubblico e che meritano la preoccupazione più condivisa da parte della cittadinanza. Penso alla legge sulla fine vita il cui varo si configura come un approdo non solo importantissimo per le famiglie che hanno al proprio interno casi riconducibili alla evocata situazione, ma anche altamente significativo per la composizione calibrata e ispirata al principio di precauzione dei beni in gioco, senza dimenticare che — come afferma la Costituzione — la salute è fondamentale diritto dell’individuo, ma anche interesse della collettività (cfr. art. 32). Ci si augura cordialmente che il provvedimento — al di là dei tatticismi che finirebbero per dare un’impressione errata di strumentalità — non si imbatta in ulteriori ostacoli, ottenendo piuttosto il consenso più largo da parte del Parlamento.
Il tema della famiglia resta cruciale nella sensibilità comune come anche nell’attenzione dei media. La denatalità è un’emergenza dai contorni obiettivamente allarmanti. L’Italia del 2040 o del 2050 chiede, anzi supplica l’Italia di oggi, a porre mente alle questioni che stanno compromettendo alla radice le condizioni per un affidabile equilibrio demografico. Su questo tema è in elaborazione il nuovo Rapporto-proposta da parte del nostro Comitato per il Progetto culturale.
Il lavoro che manca, o è precario in maniera eccedente ogni ragionevole parametro, è motivo di angoscia per una parte cospicua delle famiglie italiane. Questa angoscia è anche nostra: sappiamo infatti che nel lavoro c’è la ragione della tranquillità delle persone, della progettualità delle famiglie, del futuro dei giovani. Vorremmo quindi che niente rimanesse intentato per salvare e recuperare posti di lavoro. Vorremmo che si riabilitasse anche il lavoro manuale, contadino e artigiano. Vorremmo che scattasse da subito tra le diverse categorie un’alleanza esplicita per il lavoro che va non solo salvato, ma anche generato. Vorremmo che i giovani, in particolare, avvertissero che la comunità pensa a loro e in loro scorge fin d’ora il ponte praticabile per il futuro. Le manifestazioni giovanili in atto, in diverse piazze europee, non possono essere liquidate da alcuno con sufficienza.
Infine è la scuola, tutta la scuola, che dobbiamo amare con predilezione, qualificando certo la spesa ma non prosciugando risorse che lasciano scoperti servizi essenziali come le materne, il tempo pieno, le scuole professionali, la ricerca.
Accennavamo prima alle insurrezioni che dal mese di gennaio sono in atto nel Nordafrica e nel vicino Medio Oriente. Il caso della Libia ci ha coinvolto fatalmente di più per evidenti motivi di vicinanza geografica, ma anche perché la repressione là intentata ha finito per provocare una reazione dapprima esitante, poi confusamente accelerata, da parte di singoli Paesi occidentali e infine della Nato stessa, autorizzata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. C’è da dire che la non chiarezza emersa al momento dell’ingaggio, ha continuato a pesare sullo sviluppo temporale e strategico delle operazioni che avrebbero dovuto avere la forma dell’ingerenza umanitaria, e hanno ugualmente causato gravissime perdite umane, anche tra i civili. Difficile oggi non convenire che nel concreto non esistono interventi armati «puliti». È, questo, allora un motivo in più per intensificare gli sforzi che portino ad un cessate il fuoco, e quindi a sveltire la strada della diplomazia, preservando l’incolumità dei cittadini e garantendo l’accesso agli indispensabili soccorsi umani. Con ciò ci uniamo alle parole accorate del Papa: «la via del negoziato e del dialogo prevalga su quella della violenza, con l’aiuto degli Organismi internazionali che già si stanno adoperando nella ricerca di una soluzione alla crisi» (Appello al Regina Caeli, 15 maggio 2011).
Non può non colpire tuttavia il diverso atteggiamento adottato a livello internazionale tra la disponibilità all’interposizione armata e l’indisponibilità a suddividere il carico delle conseguenze umanitarie che lo scontro armato determina. Il nostro Paese, con la sua esposizione geografica, si è trovato e rimane in prima linea sul fronte degli aiuti e soprattutto della prima accoglienza per gli sfollati, i profughi e i richiedenti asilo che giungono sulle coste italiane, le quali sono ad un tempo il confine sud dell’Europa. Va da sé che se non avanza un più maturo senso di condivisione circa le responsabilità comuni, si aprono nel processo di integrazione falle di difficile rimedio. Ovvio che i cittadini d’Europa sinceramente comunitari vogliano a questo punto capire perché per i missili c’erano soldi e intesa politica, mentre per i profughi non ci sono i primi ed è inesistente la seconda. Quando è di ogni evidenza ormai la necessità di individuare una «via africana» verso il futuro, che dia speranza a quei giovani ma coinvolga significativamente anche i popoli dell’Occidente. Non tutto bisogna dirlo ha prontamente funzionato nei dispositivi di accoglienza messi in campo dalle autorità italiane, come non sono mancati i momenti di incertezza, o di esitazione nel mantenere gli impegni già presi. In generale però il Paese non può non essere fiero di quel che infine gli è riuscito complessivamente di offrire, a cominciare dalla gente di Lampedusa che, pur stressata da mesi di tensione e pur preoccupata per la prossima stagione turistica, ha saputo dar prova di un altruismo eroico, portando in salvo i naufraghi dell’ennesima imbarcazione incagliata nelle rocce. La visita che il 18 maggio scorso ho compiuto nella piccola isola, era un segno di vicinanza di noi vescovi al pastore di quella Chiesa, monsignor Francesco Montenegro, e voleva avere il senso dell’ammirata solidarietà e della concreta amicizia da parte dell’intera comunità ecclesiale a quell’avamposto d’Italia che così bene sa interpretare il valore dell’accoglienza nonostante tutto, nonostante tante condizioni avverse: sia di esempio e di efficace stimolo per l’intera comunità nazionale. Questo il Santo Padre ha chiesto a noi e a tutti di fare, senza la paura per il diverso e lo straniero, giacché è proprio ciò che viene messo in campo che contribuisce al riconoscerci fratelli (cfr. Benedetto XVI, Discorso all’assemblea cit.).
(©L'Osservatore Romano 23-24 maggio 2011)