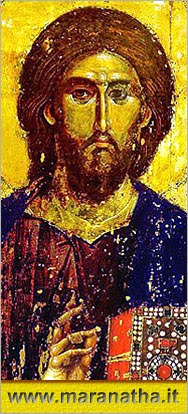Chi è il professore di teologia
Parlare di Dio poiché con Dio si parla
Pubblichiamo il discorso di ringraziamento pronunciato nel corso della consegna del «Premio Ratzinger».
di Maximilian Heim
Essendo il più giovane dei premiati, mi sia consentito di rivolgere a lei, Santo Padre, a lei, Eminenza, e a tutta l’assemblea, le mie parole di ringraziamento. Confesso che in confronto all’opera teologica degli altri premiati — è con sincera umiltà che prendo la parola. L’espressione tratta dalla Regola di san Benedetto, a lei Santo Padre molto cara, mi conforta e mi dà coraggio: Quia saepe iuniori dominus revelat quod melius est.
In qualità di professore di Teologia, di vescovo e ora come sommo pastore della Chiesa universale, lei ha, in modi diversi, influenzato, formato e dato ai tre premiati una speciale impronta.
Vorrei ora, qui di seguito, aggiungere alcuni pensieri sul professore di teologia.
Una specificità della fede cristiana che emerge è il suo elemento «intellettuale». Già nel mandato di Gesù per la missione si legge euntes ergo docete omnes gentes. Il Risorto ci manda nel mondo per insegnare alle genti: Egli vuol essere riconosciuto — Egli vuol essere conosciuto e amato.
Questo non è per nulla ovvio. Noi possiamo entrare in contatto con Dio, che è la Verità, in modo personale, del tutto personale. Tuttavia, bisogna sempre ricordare che l’esigenza di verità della fede non si lascia semplicemente confinare nell’ambito soggettivo.
Santo Padre, lei è — per alcuni di noi già da sessant’anni — un maestro che forma i propri allievi: qualcuno che, con occhio vigile e profonda intuizione, è attento al nostro tempo e partecipa ai suoi travagli e che proprio per questo resiste alle soluzioni troppo semplicistiche dello spirito del tempo. Anche lei si è formato sui Padri della Chiesa e sui grandi pensatori della Scolastica, in particolare su Agostino, Bonaventura e su teologi contemporanei, come Gottlieb Söhngen.
Per Agostino, come per Bonaventura, un maestro umano è sì capace di indirizzare lo sguardo dell’allievo, ma il vero insegnamento proviene dalla Verità stessa. Continuando nei termini dell’immagine: «l’insegnante esterno» apre le imposte affinché la luce possa entrare. In tal modo egli risveglia il coraggio della verità, verità che si manifesta attraverso la funzione dell’insegnante.
L’insegnante, nel vero senso della parola, è la Verità stessa, Verità che, in ultima analisi, è Cristo. Così anche all’allievo è possibile vedere «Colui» che l’insegnante vede. La responsabilità dell’insegnante sta nel fatto che egli stesso deve essere uno che ama la verità e cerca di approfondirla e, in secondo luogo, desidera essere formato dalla verità stessa. Egli è consapevole di essere lui stesso uno che riceve dalla verità.
Un insegnante teologo, perciò, vuole condurre l’allievo all’incontro con Dio. E dal momento che egli stesso è circondato da questa vicinanza, insegna con gioia, gioia che nasce anche dall’amore verso gli uomini che gli sono stati affidati. Questo amore e questa gioia — secondo Agostino — lo inducono a restare fedele al proprio servizio nonostante qualche delusione proveniente dal mondo esterno o da qualche travaglio interiore.
Nell’insegnamento e nella predicazione si riuniscono, in modo particolarmente speciale, l’amore di Dio e del prossimo, l’amicizia con Cristo e l’imitazione di Cristo, la contemplazione e l’apostolato, dal momento che l’insegnamento, fa notare Tommaso d’Aquino, ha in sé due oggetti: doceo aliquem aliquid. Bisogna amare Dio, del quale si parla, e amare gli uomini, ai quali ci si rivolge.
Il secondo grande maestro ad aver dato un impronta a lei, Santo Padre, forse proprio nella concezione della teologia, è Bonaventura. In lui il metodo scientifico e l’ardore spirituale, lo sforzo per la comprensione e lo zelo per le anime, raggiungono una particolare simbiosi. Il teologo, secondo Bonaventura, ha il compito, meraviglioso ma di alta responsabilità, di mettere a disposizione della Parola di Dio la propria forza espressiva — cioè di impegnarsi per l’adeguatezza, la chiarezza e la bellezza. Santo Padre, in questo, Lei, come teologo, è per noi un modello esemplare. Lei riesce a legare sempre, in modo nuovo, la chiarezza della lingua alla bellezza dell’espressione, regalando così al lettore e all’ascoltatore della parola, la gioia di Dio e della sua Chiesa. Al tempo stesso, come teologo della Chiesa, Lei è sempre attento a difendere la «semplice» fede dei piccoli (cfr. Matteo , 11, 25), resistendo con franchezza profetica ai dettami dello spirito del tempo.
Bonaventura, che, a suo tempo, difese la fede apostolica della Chiesa, ha inteso l’istituzione e l’aspirazione alla santità non in posizioni antitetiche. Come teologo, «che pensa e prega», egli ha percepito il proprio ministero proprio in questo modo. Nel suo approccio teologico, la teologia è intesa come scientia secundum pietatem, «come una scienza, che è orientata alla perfezione di tutto l’uomo nella cognizione, volontà e disposizione d’animo».
La teologia, nello studio e nella scienza, dovrebbe rafforzare nei credenti la fede degli altri e condurre al gioioso approfondimento del proprio rapporto con Dio. La teologia, così intesa, è una via verso la santità. Si tratta del sursum corda, del movimento verso Dio. Proprio in questo sta un compito particolare e duraturo della sua missione.
Ognuno di noi sa, per esperienza, che il relatore della tesi di dottorato è una figura che dà un’impronta a ogni giovane studioso. Per questo motivo, non si può non menzionare qui il teologo e filosofo Gottlieb Söhngen, la cui grandezza sta nell’ampiezza di vasta portata della sua visione, come Joseph Ratzinger si espresse in occasione del requiem del suo maestro.
Nella vita di Söhngen è chiaro che la fede non deve temere le domande da parte delle scienze, se la fede del teologo che dibatte è una fede determinata. Una fede che, per la propria esperienza con Dio, sa che il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe si è manifestato in Cristo, una fede che presuppone un decisivo atto di fede.
A mio parere, qui sta la grande chance. Come teologi possiamo cercare senza timore la verità, dal momento che il teologo non forma la verità, bensì è la verità che forma il teologo. Non potremmo quindi cercare la verità se noi stessi non l’avessimo già incontrata. Da questo incontro noi possiamo nutrire speranza e avanzare nella fede. Per questa impresa è necessario il sostegno dei grandi teologi della storia della Chiesa, soprattutto dei Padri della Chiesa e dei Dottori della Chiesa. I Padri della Chiesa sono, «veri astri che brillano da lontano». Si nutrono della Sacra Scrittura e sono interiormente vicini a Cristo, e sono dottori della Chiesa unita. Un teologo, studiando e insegnando, dovrebbe lasciarsi guidare dal ad fontes. Dobbiamo lasciarci istruire dai santi, dagli uomini che sanno che Dio solo conta, da coloro che sono esperti della tradizione e che sono ancorati alla parola di Dio.
Questa forma di teologia «esistenziale» l’abbiamo trovata in lei, Santo Padre. In lei «teologia e vita ecclesiastica si sono fuse in un tutto unico in maniera straordinaria». Lei realizza ciò che Tommaso d’Aquino, nel suo commento alla Lettera agli Efesini, osserva in modo chiaro e conciso: «L’apostolo parla di “Pa s t o r i ”, cioè di coloro a cui sta a cuore la cura del gregge del Signore»; e aggiunge subito: «E di “dottori” per mostrare che uno dei compiti essenziali è l’insegnamento (proprium officium pastorum ecclesiae est docere) della fede e dei costumi».
Vogliamo intendere la teologia come «il parlare di Dio» che proviene dal vivo incontro con Colui di cui ci è lecito parlare, incontro che ci viene regalato nella Chiesa; e intenderla come annuncio che riconduce, a sua volta, a un incontro vivo, alla preghiera.
Da teologi, vogliamo essere, insieme a lei, cooperatores veritatis, e vogliamo affrontare, con umiltà e fiducia, e senza timore, la disputa scientifica dell’universitas scientiarum, intendendo fides et ratio non come contrapposte. Con la ragione cerchiamo Dio che è la verità, il fondamento e il fine dell’esistenza umana; e facendolo «nel contesto della tradizione della fede cristiana, è stato incontestato nell’insieme dell’università».
(©L'Osservatore Romano 1 luglio 2011)