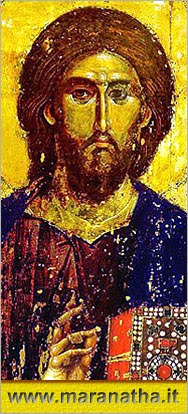Eucaristia e sacerdozio
Non c’è niente di più indispensabile
di Inos Biffi
Non c’è niente di più indispensabile
di Inos Biffi
Si va affermando — con la persuasione di proclamare chissà quale oracolo originale — che ormai nella Chiesa si deve far passare il ministero sacerdotale dalla sua fase sacrale a quella esistenziale. Una «società sacralmente impostata» è, infatti, giunta al tramonto, e una concezione cultuale di sacerdozio sarebbe estemporanea e inattuale. E qui risalta una prima anomalia: quella di collegare la dottrina della fede non alla verità ma all’attualità, alla mobilità dei gusti, o, se vogliamo, ai «segni dei tempi», la lettura dei quali, tra l’altro, brilla per arbitrio.
Dalla storia apparirebbe che se, da un lato, la comunità cristiana nasce e si sviluppa dalla Pasqua di Cristo celebrata nell’Eucaristia, dall’altro lato, per non isolarsi come una setta, assume e integra via via il linguaggio e la struttura cultuali, innestandosi nel contesto imperiale, dove il sacerdozio era asse portante della società.
Si tratterebbe ora di scollegarsi da questo contesto, e quindi di abbandonare la «sacerdotalizzazione» — per usare un vocabolo bruttissimo e quasi impronunciabile — per tornare alla cura pastorale della missione e della testimonianza.
Ma è proprio questo che la storia insegna? Per quanto si possa riconoscere in essa un’assunzione di rivestimenti e di simbologie «sacerdotali», la realtà del sacerdozio cristiano fu sempre percepita e ha sempre operato nella sua incomparabile novità: la novità di Cristo, Sommo Sacerdote eterno e intramontabile della nuova alleanza, autore del Sacrificio spirituale, celeste e glorioso, in cui offrì se stesso, una volta per tutte, nel compimento e superamento del culto levitico. È la dottrina della mirabile Lettera agli Ebrei, che effettivamente non gode eccessiva stima presso i disinvolti teologi della «decultualizzazione» — altro termine bruttissimo — i quali fanno risalire proprio a quella lettera una certa responsabilità della concezione sacralizzante del ministero cristiano.
Intanto possiamo notare che è affatto scorretto incriminare e aborrire la cultualità e la sacralità, miranti nella loro intenzione e nella loro natura a tenere vivo il senso di Dio e a suscitare e alimentare l’orazione; ed è improprio far coincidere, per ciò stesso, il culto con le pratiche puramente esteriori, formali, prive di anima e di verità e ritenute alternative alla fedeltà definita «esistenziale». Si verrebbe in tal modo a svalutare tutta la portata relativa al culto, che è invece fondamentale nella storia dell’antica alleanza. Gesù stesso con la sua famiglia non ha mancato di prendere parte alle osservanze religiose del suo popolo.
Precisato questo, possiamo sentire, in particolare, alcuni insegnamenti impartiti a inesperti alunni in preparazione al ministero, o quanto meno da essi recepiti. Per esempio questi: che il Nuovo Testamento passa da una concezione cultuale del sacerdozio a una concezione esistenziale, che abolisce la prima; che il solo sacerdote è Gesù nella sua vita e morte e poi il cristiano che «offre il suo corpo» (Romani, 12, 1).
Indubbiamente, e lo abbiamo visto dalla Lettera agli Ebrei, Gesù è l’unico Sommo Sacerdote, e il suo è l’unico e inesausto sacrificio; ed è ugualmente vero che il cristiano «offre» la sua stessa vita come sacrificio. Tuttavia, non è meno vero che lo stesso Gesù ha istituito un sacerdozio gerarchico, che certo non si «aggiunge» al sacerdozio di Cristo, bensì lo «rappresenta» sacramentalmente e opera in persona Christi.
Il sacerdote può consacrare lo stesso Corpo di Cristo, in quanto, scrive Tommaso d’Aquino, «non opera d’autorità propria, bensì per l’autorità di Cristo» (Super epistolam ad Hebraeos Lectura, 343): «Tutta la sua dignità deriva da Cristo» (ibidem, 345).
Neppure è corretto ritenere che dal sacerdozio cristiano sia eliminata la dimensione cultuale: è esatto invece che il sacrificio di Cristo avvera l’anima del culto divino, che in lui avviene «in spirito e verità» (Giovanni, 4, 23) in quanto suprema adorazione del Padre da parte di Gesù, che a lui si dona e per lui si consuma totalmente. E, se il cristiano è chiamato all’offerta del suo corpo, questa stessa offerta vale, se avviene in comunione e in continuazione con l’offerta, quindi con l’adorazione — diciamo ancora: con il culto — di Gesù Cristo sulla croce. Viene in mente l’espressione dell’antico Sacramentarium Veronense, citata dalla Sacrosanctum concilium: «In Cristo avvenne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e ci fu data la pienezza del culto divino» (5).
Si afferma, ancora, che secondo Gesù il compito dei pastori — presbiteri o episcopi — è la trasmissione e la custodia della fede attraverso la predicazione del Vangelo; che se si parla di sacerdozio o di liturgia lo si fa in senso traslato: Paolo chiama sacro ministero il suo annuncio, facendone offerta gradita (Romani, 15, 15-16).
È vero che l’Apostolo si definisce «liturgo di Cristo» e che chiama un «esercizio» o una «funzione sacerdotale» («sacro ministero») l’annuncio del Vangelo di Dio, perché gli uomini vengano offerti in sacrificio a Dio; ma non è affatto vero che nella comunità cristiana sia scomparsa la liturgia come celebrazione e atto di culto. Si deve invece ripetere che l’unico sacerdozio a valere assolutamente è quello di Cristo; che la pienezza del culto è l’offerta sacrificale che Gesù fece di se stesso sulla croce, e che questa offerta è predicata, secondo lo stesso Paolo, dalla celebrazione consistente nel «mangiare la cena del Signore»: «Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore» (1 Corinzi, 11, 20. 26).
Quanto alla missione affidata da Gesù agli Undici: essa consiste senza dubbio nel predicare, ma anche nel battezzare: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli» (Matteo, 28, 19).
Vediamo poi che nell’Ultima Cena Gesù affidò agli apostoli il suo Corpo dato e il suo Sangue sparso — ossia la sua morte gloriosa e il suo mistero della salvezza — col mandato: «Fate questo in memoria di me» (Luca, 22, 19-20). La celebrazione dell’Eucaristia appare allora fondamentale per il ministero del Nuovo Testamento.
E, infatti, a spiccare e a distinguersi da subito è «il primo giorno della settimana» quale giorno dello «spezzare il pane» e quindi della liturgia cristiana, dell’esercizio del sacerdozio ministeriale, della fattiva fraternità.
I pastori pascono il gregge di Cristo certamente con la Parola, ma non è proprio questa Parola incarnata e fatta sacrificio, che viene resa presente e spezzata per il nutrimento del Popolo di Dio? Nessuna esitazione allora a riconoscere che il sacerdote del Nuovo Testamento, riflesso di Gesù Sommo Sacerdote, va radicalmente e anzitutto concepito in funzione della celebrazione del Corpo e del Sangue di Cristo, cioè per l’esserci della liturgia del Sacrificio di Gesù, perenne sorgente dell’identità della Chiesa.
A ben vedere certe affermazioni da parte di improvvidi maestri si possono fare perché non si comprende il senso della presenza sacramentale del Corpo e del Sangue di Gesù, finalizzati non a una pura presenza rituale, ma a una efficacia «reale».
Non si tratta di «desacerdotalizzare» la Chiesa di oggi, ma di ravvivare in essa il senso dell’Eucaristia e quindi il servizio al sacerdozio e al sacrificio di Cristo.
Ben intesa, l’azione liturgica del pastore d’anime non isola affatto dalla comunità, non blocca l’immischiarsi a essa — come si ama dire con espressione sonora e confusa — non condiziona la valorizzazione della responsabilità dei fedeli, non chiude il pastore d’anime nella sua soddisfatta e incombente autorità, né lo sottrae all’apostolato libero e povero per la missione.
Questa alternativa tra la «pietà» o la devotio christiana, da una parte, e la testimonianza e dedizione popolare, dall’altra, è clamorosamente smentita dalle grandi figure dei santi della carità e della missione, che esattamente nella celebrazione sacerdotale trovavano, e continuano a trovare, impulso e forza.