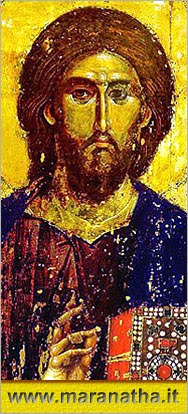Alla radice del ministero episcopale
Servi umilissimi della Parola di Dio
Pubblichiamo una meditazione sul tema della Parola di Dio e la persona del vescovo, tenuta dal cardinale prefetto della Congregazione per i Vescovi a un’assemblea di presuli brasiliani riuniti nel santuario di Nostra Signora di Aparecida.
di Marc Ouellet
«In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: “Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare”» (Luca, 10, 21-22).
Alla luce di questa esultanza profonda di Gesù, rivelatrice della sua identità trinitaria, affronto il tema della Parola di Dio e la persona del vescovo. Questo tema mette in evidenza la persona del vescovo rispetto alla sua missione in un senso che chiarisce il contesto del passo di san Luca. L’evangelista pone in effetti l’esultanza di Gesù nel quadro del ritorno dalla missione dei settantadue discepoli che esclamano: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Gesù risponde a questo entusiasmo dei missionari con la rivelazione di un entusiasmo ancora più profondo: «Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli» (Luca, 10, 17-20).
La rivelazione che egli fa «sotto l’azione dello Spirito Santo» sembra voler mettere in guardia i discepoli contro un entusiasmo superficiale per il potere e orientarli verso la felice esperienza della comunione trinitaria, che gli è propria e che egli rivela ai piccoli. Una simile rivelazione sulle labbra di Gesù porta a pensare che la santità del vescovo non coincide pienamente con il puro esercizio del ministero; essa coinvolge anche la sua persona a un altro livello che dobbiamo ora approfondire.
L’ordinazione episcopale fa partecipare il vescovo alla pienezza del sacerdozio di Cristo. Questa grazia comporta un’identificazione con Cristo che include, oltre alla vita filiale propria del sacerdozio comune dei battezzati, un’unzione dello Spirito Santo che rende il vescovo partecipe dell’autorità del Padre di cui il Figlio è depositario. La pienezza del sacerdozio si ricollega a questa seconda dimensione, che rimanda al mistero del Padre. Non si dovrebbe pensare che l’esercizio generoso di questa seconda dimensione del sacerdozio basti a procurare al vescovo la santità alla quale aspira dedicandosi al servizio del suo popolo? La nostra missione pastorale non è forse il cammino della nostra realizzazione come persone?
Dobbiamo ricordare qui che Cristo è il solo in cui la Persona e la missione coincidono in modo assoluto. Egli è «l’Inviato del Padre» (è degno di nota il fatto che in Giovanni il termine «inviato» per designare il Figlio compaia quarantadue volte; tale ripetizione che attraversa tutto il suo Vangelo è proprio per farci comprendere questa dinamica dell’identità del Figlio indissolubilmente legata alla sua missione). Tutto il suo essere, dal primo momento della sua incarnazione fino alla sua morte e alla sua risurrezione, è vissuto come il compimento della volontà salvifica universale del Padre. «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera» (Giovanni, 4, 34; cfr. anche Hans Urs von Balthasar, La dramatique divine, II. Les personnes du drame, 2- Les personnes dans le Christ, Paris, Lethielleux, pp. 119- 200).
In noi, suoi ministri, la missione non coincide pienamente con la nostra persona, poiché siamo stati chiamati in un momento preciso, abbiamo detto sì e dalla nostra ordinazione siamo investiti del carisma di annunciare la Parola di Dio per condurre il nostro popolo all’obbedienza della fede. Nell’esercizio del nostro ministero constatiamo che alla santità obiettiva del Signore che dimora in noi non corrisponde sempre — e di fatto mai perfettamente — la santità soggettiva che ci sforziamo di vivere ogni giorno. Da qui la tensione inerente al nostro ministero fra la nostra persona e la nostra missione.
L’esortazione Pastores gregis riconosce implicitamente questa tensione quando afferma: «Si potrebbe dire che, nel Vescovo, missione e vita si uniscono in maniera tale che non si può più pensare ad esse come a due cose distinte: noi Vescovi siamo la nostra missione. Se non la compissimo, non saremmo più noi». E conclude: «È nella testimonianza della nostra fede che la nostra vita diventa segno visibile della presenza di Cristo nelle nostre comunità» (n. 31). Come assicurare questa unità fra la nostra vita e la nostra missione pastorale, pur riconoscendo che il divario fra la santità obiettiva di Cristo che agisce attraverso di noi e la nostra santità soggettiva resta insormontabile? Porre tale domanda corrisponde a interrogarci non solo sulla funzione che viene esercitata, ma anche sulla persona che l’esercita, la cui intima identità affonda le sue radici nel mistero di Dio uno e trino. L’uomo è stato in effetti creato a immagine e somiglianza di Dio che è Amore trinitario. Si realizza come persona nel dono di sé, a immagine di Dio, in comunione con Gesù Cristo, sommo sacerdote della Nuova Alleanza. La persona del vescovo è configurata a Cristo in quanto Capo e Sposo della Chiesa. È oggettivamente santificato da lui per servire alla santificazione del popolo di Dio. Il suo carisma è essenzialmente «per gli altri» ed esige che la sua persona e la sua missione si avvicinino il più possibile all’identità di Cristo. Vediamo questa tensione all’opera nell’esercizio del munus sanctificandi.
La sera del Giovedì santo, Cristo compie gesti che stabiliscono le disposizioni fondamentali della Nuova Alleanza. Ama fino al limite estremo dell’amore, abbassandosi a lavare i piedi dei suoi discepoli, simbolo del suo supremo abbassarsi dell’indomani; istituisce un nuovo rito pasquale in memoria della sua passione, della sua morte e della sua risurrezione; e consacra i suoi apostoli sacerdoti della Nuova Alleanza: «Fate questo in memoria di me» (Luca, 22, 19).
Le stesse parole e i gesti con cui Cristo si consacra, sono quelle che anche consacrano gli apostoli nella verità del suo amore trinitario (cfr. Giovanni, 17, 17). Il fondamento del sacerdozio è dunque l’istituzione della santa Eucaristia in quanto memoriale del mistero pasquale. Questo «memoriale» ricapitola, nel senso biblico forte di presenza dei mirabilia Dei, la storia della prima alleanza e porta al suo compimento l’alleanza nuova ed eterna nel sangue del Crocifisso-Risorto. La Parola di Dio raggiunge allora l’apogeo della sua potenza creatrice e redentrice, coincidendo con il dono supremo, escatologico, di Gesù. Essa fa avvenire il Regno dell’Amore trinitario nel mondo mediante la risurrezione di Cristo e la nascita della Chiesa.
Nel suo ultimo libro su Gesù di Nazaret, Benedetto XVI ha dato un’interpretazione teologica geniale dell’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, mostrando come si riconciliano la prospettiva giovannea e quella sinottica che divergono nella cronologia degli eventi (Gesù di Nazaret. Dall’ingresso a Gerusalemme fino alla risurrezione, Libreria Editrice Vaticana, 2011, pp. 130-139). I sinottici parlano di cena pasquale, Giovanni no. Chi ha ragione? Entrambi, scrive il Papa dottore, poiché Giovanni segue la sequenza dei fatti secondo la quale Gesù, l’Agnello di Dio, doveva essere immolato alla vigilia del sabbat, quando venivano immolati gli agnelli. I sinottici parlano di cena pasquale poiché, dopo la risurrezione, si è compreso che l’ultima cena di Gesù inaugurava il rito che avrebbe fatto memoria della «sua» pasqua. In quanto tale, essa non era la continuità della pasqua ebraica, ma l’inaugurazione di un nuovo rito, di una nuova alleanza e dunque di un nuovo culto sacerdotale (Ibidem, p. 138. «Una cosa è evidente nell’intera tradizione: l’essenziale di questa cena di congedo non è stata l’antica Pasqua, ma la novità che Gesù ha realizzato in questo contesto. Anche se questo convivio di Gesù con i Dodici non è stata una cena pasquale secondo le prescrizioni rituali del giudaismo, in retrospettiva si è resa evidente la connessione interiore dell’insieme con la morte e risurrezione di Gesù: era la Pasqua di Gesù. E in questo senso Egli ha celebrato la Pasqua e non l’ha celebrata: i riti antichi non potevano essere praticati; quando venne il loro momento, Gesù era già morto. Ma Egli aveva donato se stesso e così aveva celebrato con essi veramente la Pasqua. In questo modo l’antico non era stato negato, ma solo così portato al suo senso pieno»).
La lettera agli Ebrei sviluppa a fondo questa nuova prospettiva nel suo insegnamento su Cristo sommo sacerdote di un nuovo sacerdozio: «Poiché è impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrifico né offerta, un corpo invece mi hai preparato (...) Ecco io vengo per fare la tua volontà» (Ebrei , 10, 4-5). Prendendo il pane e pronunciando la benedizione, Gesù dice: «Questo è il mio corpo, che è per voi». Poi, alla fine della cena prende il calice e dice: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». (1 Corinzi, 11, 23-26).
Queste parole di Gesù operano ciò che significano. Trasformano il pane e il vino nel suo corpo e nel suo sangue. È la fede della Chiesa conservata fin dalle origini, nonostante le ricorrenti negazioni e le riduttive interpretazioni. «Fate questo in memoria di me». La Chiesa ha compreso che il vescovo o il sacerdote che pronunciano questa parole agiscono in persona Christi. Cosa vuol dire in fondo questa misteriosa espressione in persona Christi?
Occorre scartare qui un certo numero di interpretazioni carenti. Non basta dire, per esempio, che la mera obbedienza all’ordine di Cristo opera miracolosamente la transustanziazione; non basta neppure dire che queste parole pronunciate dal sacerdote realizzano ciò che dicono semplicemente perché lo Spirito Santo invocato agisce sulle oblate; dobbiamo arrivare a dire che queste parole sono uniche ed escatologiche. Sono pronunciate nell’unità dalle tre Persone divine, anche se sono pronunciate sacramentalmente dal Verbo incarnato. La liturgia del Giovedì santo ci ricorda inoltre che sono sempre pronunciate «oggi», ossia come se fosse per la prima e unica volta. Ogni volta che un ministro ordinato pronuncia queste parole sacramentali, Cristo ne conserva l’attualità trascendente nella potenza dello Spirito Santo che le ha glorificate una volta per tutte mediante la sua risurrezione dai morti.
In altri termini, è sempre Cristo l’autore e il soggetto attuale di queste parole che significano e compiono il suo dono escatologico all’umanità. Sono parole escatologiche poste sulla nostra bocca di ministri storici della Nuova Alleanza dallo Spirito Santo che fa del Signore risorto e del suo ministro un solo soggetto sacramentale. In questa luce riflettiamo attentamente e comprendiamo che non siamo noi ad avere il potere di consacrare la santa Eucaristia. È la Parola stessa di Dio ad agire e a renderci strumenti per la sua azione. La Parola di Dio è viva ed efficace. È creatrice e ricreatrice. Noi ne siamo i servi umilissimi.
A pensarci bene, non c’è in fondo che una sola Eucaristia, una sola offerta di Cristo nella sua Pasqua. Ogni Eucaristia associa il celebrante e l’assemblea all’unico sacrificio escatologico di Cristo che vale per tutta l’umanità di ogni tempo e i cui frutti raggiungono in modo visibile e sacramentale l’umanità intera attraverso la mediazione della Chiesa, sacramento di salvezza. In ogni Eucaristia che noi celebriamo, uniti al nostro presbiterio e al popolo di Dio, è il sacerdozio di Cristo nel suo mistero pasquale che compie la sua opera di glorificazione di Dio e di santificazione del mondo.
© L'Osservatore Romano 23 luglio 2011