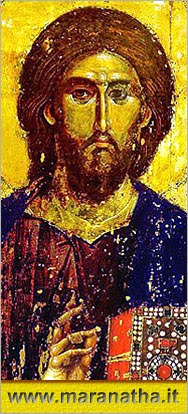Il disagio antropologico della società contemporanea
Tra le paure dell'Occidente
Sembra affievolirsi un’etica della speranza unita alla tenacia di costruire un futuro diverso
di Michele Dau
Nei primi anni del nuovo millennio paure e disagi dimenticati sono riemersi in Occidente, dopo cinque positivi decenni di speranze e di benessere crescente. Timori e sofferenze che toccano nel profondo le coscienze e i comportamenti di milioni di persone, fino a far parlare di crisi antropologica. Delle paure da sconfiggere ha parlato senza arroganza il Presidente degli Stati Uniti Barak Obama alla fine di maggio nel suo discorso al Parlamento britannico. Un vero e proprio disastro antropologico contemporaneo a danno dei giovani è stato evocato nei mesi scorsi da diversi osservatori ed esperti.
La questione non è purtroppo molto approfondita e indagata, anche se di recente alcuni ricercatori ne hanno esplorato alcuni aspetti. È l’epoca dell’incertezza sostengono molti economisti e sociologi, per le nuove sfide aperte dalla globalizzazione. È la fine di una lunghissima stagione di stabilità e di crescita e del convincimento di una quasi automatica continuità. In realtà alcuni segni di crisi profonda si potevano già scorgere da tempo, con l’apparente tramonto di valori e sentimenti fondamentali: la morte di Dio come il venir meno di un naturale sentire religioso della società; l’eclisse dell’ideale di patria come principio di identità comune profonda; la fine della famiglia come dimensione esistenziale normale.
Altri hanno poi descritto con enfasi la fine del lavoro come effetto delle rivoluzioni tecnologiche e l’aprirsi di enormi spazi di tempo liberato, ingenerando così l’idea di una svalutazione del lavoro stesso. Di queste morti e di questi declini si è alimentata molta letteratura e cultura, senza però andare troppo al fondo dell’angoscia e della disperazione che ha coinvolto, ad esempio, larghe fasce di giovani negli anni Settanta e Ottanta, fino alla manifestazione anche di fenomeni di violenza su di sé o sugli altri.
La Fondazione Censis nelle settimane scorse ha esplorato, con il supporto di dati e indicatori oggettivi, alcune facce del malessere odierno, del disagio antropologico che riguarda la società contemporanea. L’analisi muove dalla messa in luce del crescente primato delle pulsioni soggettive e della sregolatezza («faccio quello che voglio io»). Torna alla mente quanto scriveva John Henry Newman al Duca di Norfolk «la coscienza è una severa consigliera, ma è stata rimpiazzata da una sua contraffazione: è il diritto ad agire a proprio piacimento».
Nel paesaggio umano cresce il rinserramento nel proprio interesse «particolare», rifiutando così ogni socialità. La ricerca del benessere immediato e la coazione al consumo sono i tratti di una fenomenologia individuale e collettiva proiettata nel presente, dove trionfa ciò che è immanente e non c’è spazio alcuno per il trascendente.
Questa ricognizione apre squarci importanti e chiama ad altre considerazioni con l’auspicio che il coraggio intellettuale non si nasconda. Alcuni aspetti più strutturali potrebbero, infatti, aiutare a spiegare quello che accade e a definire le modalità per superare le difficoltà. Un malessere significativo, ad esempio, si manifesta nei cosiddetti ceti medi che, fino a quando la crescita economica appariva stabile e progressiva, avevano forse immaginato un approdo a livelli sociali più evoluti e borghesi. Le difficoltà degli ultimi anni hanno gettato nello sconforto centinaia di migliaia di famiglie occidentali che hanno visto arrestarsi l’ascensore sociale e si sono viste proiettate di nuovo verso il basso. Nel periodo medio, anche nel ricco Occidente, potrebbero così tornare ad aumentare le disuguaglianze sociali, accrescendo non poco il disagio e l’inquietudine.
Non meno rilevante è la perdita di autorevolezza della scuola, intesa come sistema di formazione, di crescita sociale, di valutazione del merito. L’Ocse segnala da anni la necessità di nuovi investimenti nella preparazione del capitale umano, nella formazione degli stessi insegnanti e nella loro valorizzazione, come premessa indispensabile del progresso culturale e civile collettivo.
Un altro aspetto sistemico, importante e sottovalutato, è la questione del rapporto fra generazioni, o meglio dei problemi individuali e sociali posti dal prodigioso allungamento della vita che non ha precedenti nell’esistenza umana. Nei Paesi più avanzati si è passati da una speranza di vita di 55 anni nel 1930 agli 80 di oggi. Le medie statistiche, come è ovvio, incrociano chi vive meno e chi di più, con il risultato però, di consegnarci in vita numerose generazioni di anziani, in accettabili condizioni di salute. È il risultato di conquiste straordinarie del progresso sociale, dell’alimentazione, della medicina. Si osservano, però, oggi, da un lato un numero crescente di anziani inseriti nella vita sociale e di relazione, dotati di un qualche patrimonio (quantomeno la prima casa) e di qualche rendita, e dall’altro lato una preoccupante caduta del tasso di natalità che accentua l’invecchiamento medio della popolazione «incapace perfino di rinnovarsi biologicamente» (Sollicitudo rei socialis, 25).
Milioni di persone senescenti senza una specifica educazione a questa inattesa condizione di massa. Anziani che hanno figli già adulti e nipoti non più adolescenti. Anziani che esercitano ancora influenza che interferisce nella vita delle generazioni più giovani. Vi possono essere aspetti paradossali nelle situazioni che si possono vedere, ma è certo che vi sono anche deformazioni esistenziali, ovvero situazioni mai vissute e immaginate che condizionano non poco la crescita dei giovani. Ne hanno parlato numerosi scrittori e analisti della condizione giovanile, per evidenziare qualcosa di più e di diverso di una semplice ostruzione sociale.
In questo contesto umano «invecchiato» può essere poi superficiale fare riflessioni critiche sui limiti di certe reazioni giovanili: da quelle un po’ totalizzanti successive al Sessantotto a quelle degli odierni indignados delle piazze europee. Certo la gran parte sono giovani ai quali non manca un tetto, né mezzi per muoversi e comunicare, né soldi in tasca per l’ennesimo aperitivo. Manca per molti però un inserimento sociale e una responsabilità vera.
Ma chi ha educato queste generazioni? Chi le ha protette oltre ogni limite, togliendo loro, se possibile, ogni difficoltà anche minima da superare? Preparando per loro, finché erano meno consapevoli, ogni concreta risposta materiale, e proseguendo in questa linea anche quando i ragazzi non erano più tali e dovevano spiccare il salto dal nido? È la condizione nuova delle famiglie lunghe, che comprendono cioè più generazioni. Una situazione non semplice, sulla quale c’è un obiettivo ritardo nella riflessione sociale, culturale e forse anche pastorale.
C’è come un inconsapevole gene egoista nella generazione anziana, che si sente al centro e indispensabile, che non riesce a svolgere la propria vita e proietta la propria dimensione esistenziale nella medesima area vitale dei giovani, con l’obiettivo di dare sostegno, ma anche con il rischio vero di soffocare, di rappresentare una esistenza artificiale perché artatamente semplificata. Non c’è la capacità di volgere lo sguardo verso altri, verso situazioni che magari avrebbero bisogno di attenzione e di cura. Si rimane attaccati solo al proprio ambito particolare.
Non è questa certo una analisi facile, perché si rischia di cadere nella lesione della sapienza e dell’esperienza dei vegliardi, o di accreditare l’idea sbagliata dell’abbandono degli anziani. Si potrebbe qui richiamare la saggezza di Seneca e il suo «egregia cosa è imparare a morire», o anche la magnifica sapienza retorica di Cicerone che ricorda «il vero responsabile di tutto non sono gli anni, è il carattere». Emerge ancor di più la forza dell’insegnamento biblico e la necessità di favorirne l’inveramento quando dice che le persone «nella vecchiaia daranno ancora frutti» (Salmi, 92, 15).
Non si tratta perciò di togliere ai padri per dare ai figli, come hanno scritto alcuni analisti, né di mettere gli uni contro gli altri. Quanto piuttosto di lasciar crescere i giovani, di accettare che possano sbagliare, di ammetterne con pazienza gli errori. C’è un senso di infallibilità e di certezza che le generazioni anziane vorrebbero diffondere come estremo contributo a riparare i giovani dalle incertezze del tempo presente. Ma forse le generazioni più giovani dopo la guerra avevano davvero meno sfiducia? O avevano di fronte solo macerie e alle spalle orrori indicibili da cui fuggire? Forse i disagi antropologici attuali non sono quelli delle generazioni che hanno vissuto in Europa il secondo conflitto bellico e le sue assurde tragedie. Ma la profondità delle inquietudini è notevole e la tensione positiva è debole ovunque. Sembra affievolirsi un’etica della speranza unita alla tenacia di costruire un futuro diverso.
Che cosa accomuna queste generazioni, le une condizionate dalle altre per un tempo più lungo del passato? Vi è un tratto di fondo che emerge, anche nell’opinione dei più acuti osservatori: è la paura della complessità esistenziale e sociale che spinge anziani e giovani a rifugiarsi nel presente, a rinunciare a costruire insieme il futuro nel giorno per giorno attento a guardare in faccia la realtà come si presenta.
È il timore di una complessità sempre meno comprensibile, perché sempre più rifiutata, in nome di una domanda di semplificazione che riguarda ogni cosa, dalla vita personale a quella civile. La complessità di una società che evolve e si apre, a culture e persone diverse, a fenomeni nuovi come quelli dell’allungamento generazionale, a condizioni esistenziali diverse dal passato in occidente come quelle libere dai bisogni primari, ma anche povere di capacità relazionali articolate.
La chiusura verso la complessità è il sintomo più grave di tutti, perché si porta dietro il rigetto della crescita della persona e della sua coscienza e il rifiuto stesso della costruzione della comunità che si presenta sempre meno come un bene naturale e sempre di più come qualcosa da edificare con iniziativa paziente.
Questa panoramica non può altresì tralasciare la differenza che può esistere tra le paure e il disagio della gente comune e quello delle classi dirigenti. Nei secoli moderni i gruppi dirigenti — costituiti dall’intreccio tra i poteri regali e aristocratici, quelli ecclesiastici e quelli civili ed economici — hanno sofferto di paure escatologiche, della morte, della contaminazione idolatrica e dell’eresia. Timori che potesse venir meno un potere assoluto, per morte fisica o per dissacrazione ideologica.
Nella contemporaneità i gruppi dirigenti non sembrano guardare oltre il presente, rinserrati nella conservazione di quello che si è raggiunto, dimentichi che la forza stessa delle società più avanzate è nella capacità di proporre e attualizzare ogni giorno la propria socialità dinamica, la forza del proprio umanesimo integrale. Il senso di un progetto comune sembra affievolirsi, e quando una classe dirigente non si distingue più nel corpo sociale vuol dire che ha rinunciato a rappresentarlo e a orientarlo con lo sguardo lungo saldamente rivolto oltre l’orizzonte.
Le risposte a questi importanti fenomeni sono antiche e nuove insieme. Vi è anzitutto la sfida di educare, di mettersi in gioco, di incontrare l’altro e di crescere con lui. Educare significa tirare fuori qualcosa che è dentro, ma anche condurre. È il compito di tanti quello di sostenere la libera formazione delle coscienze e delle personalità. È soprattutto un dovere dei gruppi dirigenti, di quelli che si sentono tali. Una sfida educativa che riguarda anzitutto gli stessi educatori, perché abbandonino la paura e i timori e riscoprano la necessità e l’urgenza «di una grande opera educativa e culturale» (Centesimus annus, 36). Una sfida rivolta a tutti, agli anziani e ai giovani, perché trovino più intensamente se stessi, perché non disertino la scena complessa della vita e si accompagnino reciprocamente con più libertà. Una sfida a costruire la città terrena, a vivere la crisi come trapasso continuo verso una dimensione di relazioni umane che non sfuggono dal quotidiano ma che non ne rimangono imprigionate.
Il non abbiate paura evangelico si dovrebbe coniugare con la speranza e la carità. Tra la promozione umana e l’evangelizzazione ci sono infatti legami profondi. In primo luogo «legami di ordine antropologico perché l’uomo da evangelizzare non è un essere astratto, ma è condizionato dalle questioni economiche e sociali (Evangelii nuntiandi, 36). Un legame che richiama a una piena attuazione della Costituzione conciliare Gaudium et spes e alla sua attenzione ai cambiamenti sociali, psicologici, politici, economici, morali e religiosi che stimolano sempre di più la preoccupazione pastorale della Chiesa per i problemi degli uomini e il dialogo con il mondo. Un progetto educativo cristiano che irrompe nel presente e fa emergere il senso vitale di ciascuno all’interno di un percorso comune.
© L'Osservatore Romano 16 luglio 2011