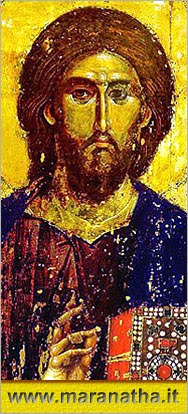Un’avventura per la felicità
Pubblichiamo, quasi integralmente, il testo dell’intervento intitolato «Un nome per l’eternità. Piccola teologia della vocazione sacerdotale» che l’arcivescovo segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica ha tenuto il 2 luglio scorso durante l’incontro annuale dell’European Vocations Service, organizzato a Horn, in Austria, dalla commissione del Consiglio delle conferenze episcopali d’Europa
di Jean-Louis Bruguès
Ogni vita cristiana è un’avventura. Essa inizia da una chiamata che il Signore ci lancia al momento del nostro battesimo. Noi passiamo la nostra esistenza a decifrare questa chiamata: «Che cosa il Signore attende da me?», poi a rispondervi. La risposta buona ci è donata in uno dei più bei racconti di vocazione che troviamo nella Bibbia. Al fanciullo Samuele che aveva sentito pronunciare il suo nome diverse volte nella notte, l’anziano Eli consiglia di dire: «Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta» (1 Samuele, 3, 9). Da questo racconto, prendo quattro spunti di riflessione: la chiamata risuona nella notte, essa conserverà dunque sempre, anche davanti ai nostri occhi, un aspetto misterioso e incomunicabile; essa può essere indirizzata a noi presto nella nostra esistenza (Samuele è molto giovane); essa riveste sempre una forma personalizzata (Samuele è chiamato con il suo nome, mentre gli altri non sentono nulla); una terza persona è necessaria per autenticarla, perché essa risuona nell’oscurità (in questo caso, il profeta Eli).
Per i cristiani, ripetiamolo, il primo momento in cui risuona la chiamata è il battesimo. Nel momento in cui riceviamo il nostro nome, Cristo ci sceglie. Egli segna, se lo posso dire, la sua proprietà: che noi lo sappiamo o no, che noi lo vogliamo o no, siamo suoi. Come un Dio geloso, egli ci sussurrerà fino al nostro ultimo soffio: «Tu sei mio, tutto mio. Tu mi appartieni per sempre, e mai distoglierò il mio volto da te. Ho impresso in te un segno indelebile; ho concluso con te un’alleanza eterna. Tu puoi fingere di non aver sentito nulla, tu puoi distoglierti da me, tu puoi comportarti come se questo battesimo non fosse mai esistito, perché io non amo che uomini liberi. Tu puoi anche rischiare l’avventura con me, tu puoi rispondere alla mia amicizia per te con un’amicizia per me. Sappi tuttavia che ti ho donato un nome, e questo nome ti segna per l’eternità».
A questa avventura, la tradizione cristiana dona il bel nome di santità. La chiamata alla santità percorre tutta la Bibbia: «Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo» (Levitico, 19, 2; noi potremmo tradurre ugualmente bene: «Siate santi come io sono santo»). Questa santità potrebbe sembrare terribilmente lontana, perfino impossibile: come imitare la santità di un Dio che non si vede, che non lo si può nemmeno avvicinare sotto pena di morire? Con la sua incarnazione, Cristo, egli che è l’immagine perfetta, ha reso sensibile l’immagine del Dio invisibile. La santità si è fatta, grazie a lui, più vicina, più raggiungibile, vorrei dire più familiare. «Io sono mite: anche voi siate miti». «Io sono misericordioso: anche voi siate misericordiosi ». Noi possiamo declinare così ciascuna delle beatitudini. Per i battezzati, la santità consiste, dunque, in una imitazione della santità di Cristo. Il concilio Vaticano II ricorda in maniera opportuna — perché questo aspetto avrebbe potuto essere cancellato nel corso degli ultimi secoli — che la chiamata alla santità si indirizza a tutti i battezzati senza eccezione: «tutti i fedeli cristiani, di qualsiasi stato o ordine, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità» (Lumen gentium, 40). Per un battezzato, la santità non è una opzione, ma un obbligo.
Anche se la chiamata alla santità è indirizzata a tutti, essa riveste sempre una forma personalizzata. Ritroviamo qui l’importanza del nome: Dio chiama ciascuno per nome e ciascuno avrà il suo proprio modo di rispondere a questa chiamata. La santità è sempre singolare: la straordinaria diversità delle personalità dei santi lo dimostra bene. In questo senso, le santità personali non sono paragonabili tra di loro; ciascuna è unica, ciascuna è originale.
La chiamata è personalizzata: «Tu, vieni dietro a me», tu, non un altro; la risposta da parte nostra è personalizzata dal nostro carattere, dalla nostra storia individuale e da tutti gli eventi che hanno tessuto la trama del nostro essere.
Noi passiamo, dunque, la nostra vita a decifrare la chiamata del Signore, avrei voglia di dire il sogno che il Signore ha nutrito per ciascuno di noi; passiamo la nostra vita, se almeno vogliamo essere fedeli al nostro battesimo, a rispondere a questa chiamata. Voi sapete che nella Bibbia il nome riassume da solo tutta la persona. Qui il nome giustifica una doppia personalizzazione. Personalizzazione di Colui che prende l’iniziativa di chiamare: «Tu, Samuele», «Tu, Filippo», «Tu, il pescatore che stai riassettando le reti», «Tu, il cambiavalute» — i Vangeli sinottici hanno avuto la buona cura di riportare ciascuna delle chiamate indirizzate ai discepoli. E personalizzazione di colui che è chiamato. La vocazione comporta così un doppio versante: oggettivo (la chiamata lanciata) e soggettivo (la risposta donata).
Nel racconto biblico di Samuele che ha aperto la nostra riflessione, abbiamo intravisto tre personaggi: il fanciullo, la voce che sveglia, la terza persona che interpreta. È che l’avventura della vocazione non si gioca a due, come potrebbe lasciar credere un approccio individualistico — io e il mio Dio — ma a tre. Chi è questo terzo partner? Per rispondere a questa domanda, bisogna ricordare che è piaciuto a Dio di fare della santità personale un’avventura collettiva. A questa avventura comunitaria, noi diamo il nome di Chiesa. La Chiesa non è altro che l’avventura comune della santità, insomma, l’avventura dell’intera umanità.
Leggiamo nel Catechismo della Chiesa cattolica: «Nella Chiesa tale comunione degli uomini con Dio mediante la carità che “non avrà mai fine” (1 Corinzi, 13, 8) è lo scopo cui tende tutto ciò che in essa è mezzo sacramentale, legato a questo mondo destinato a passare. “La sua struttura è completamente ordinata alla santità delle membra di Cristo”» (n. 773).
La messe ha bisogno di operai, la missione ha bisogno di servitori. È per questo che il Signore si sceglie dei preti. Egli chiama degli uomini a riprodurlo nel loro medesimo essere — parole, atti e fino all’identità fisica — ad agire in suo nome diventando i pastori del suo popolo. «Il presbitero è inserito sacramentalmente nella comunione con il vescovo e con gli altri presbiteri, per servire il popolo di Dio che è la Chiesa e attrarre tutti a Cristo» (esortazione apostolica Pastores dabo vobis, 12). Servire: ecco senza dubbio la parola chiave che ci permette di accedere al mistero del sacerdozio.
Perché uno piuttosto che l’altro? Perché io? Perché sono stato chiamato a diventare prete? Dio solo conosce la risposta a queste domande. Bisognerebbe qua ricordare la bella e difficile teologia dell’elezione. La Bibbia ci fa vedere, infatti, che il Signore ha sempre scelto liberamente, secondo dei criteri che non sono i nostri, con il rischio qualche volta di scandalizzarci. Perché Israele e non un altro popolo? Non era per altro il migliore dei popoli. Perché il più piccolo e non il più grande? Perché il più giovane che sembra il meno sperimentato (cfr. la scelta di Davide)? Dio sceglie con una libertà sovrana. Io non conoscerò, che quando mi troverò alla sua presenza, la ragione della mia vocazione sacerdotale. Qui, dunque, si presenta una questione cruciale: da una parte è necessario che io mi appoggi sulle mie intuizioni, sulle mie aspirazioni, sui miei desideri e persino sui miei sogni per scoprire che Dio mi chiama al suo servizio sotto questa modalità di prete; dall’altra parte, io non devo assolutizzare questi slanci della mia personalità, ma sottometterli al giudizio di un altro, della Chiesa.
Il profeta Eli ha compreso che la voce veniva da Dio, non il fanciullo che per altro era stato scelto. Solo la Chiesa autentica questa chiamata e la fa sua. A essa compete chiamare o no al ministero presbiterale coloro che si sentono attirati da lui. Era poco dopo il maggio del 1968: l’arcivescovo di Parigi era stato invitato a partecipare a una trasmissione televisiva. Si voleva interrogarlo sulla crisi del ministero. A un certo punto, mi ricordo molto bene, con stupore degli altri partecipanti, l’arcivescovo si è rivolto alla telecamera e, guardando gli spettatori in faccia, lanciò: «Ho bisogno di voi! Assumo!», come lo avrebbe fatto il padrone della messe della parabola evangelica. Egli aveva ragione: la Chiesa chiama per il servizio della sua missione il prete di cui essa ha bisogno.
Detto per inciso: abbiamo sicuramente conosciuto alcune di quelle situazioni alla fine drammatiche, in cui il candidato porta come una ferita il rifiuto del vescovo di chiamarlo. La tentazione è allora grande di ricercare un altro vescovo più comprensivo o meno lucido: queste dimissioni di seminari in seminari, più o meno onestamente condotte, rappresentano, diciamolo francamente, una piaga per la Chiesa di questo tempo.
Infatti, la Chiesa discerne le vocazioni, la Chiesa chiama al ministero presbiterale. La Chiesa forma i candidati. Quando i vescovi in visita ad limina vengono anche alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, noi ripetiamo sempre lo stesso messaggio: la formazione dei preti è molto importante; mettete nei vostri seminari i migliori dei vostri preti come educatori. Certo, questi preti mancheranno nella pastorale immediata; ma il futuro della diocesi dipende largamente dalla qualità dei futuri preti.
La Chiesa infine donerà domani ai giovani preti la missione che sembrerà la più adatta alle loro capacità. Fare nascere, educare, lanciare nella vita: se ci pensiamo bene, tutte queste attività sono per natura materne. Bisogna, dunque, riscoprire la dimensione materna della Chiesa. Un ricordo mi ritorna alla memoria. Ero andato in un grande borgo della mia diocesi. Un gruppo di otto adolescenti si preparavano a ricevere la confermazione — i primi a domandare questo sacramento dopo vent’otto anni! Mi sono meravigliato della loro naturalezza, del loro buon umore e soprattutto della loro capacità di pregare: essi entravano nelle preghiere come un’anatra nell’acqua. Essi mi hanno domandato cosa rappresentava la Chiesa per me: gli ho risposto che avevo appreso ad amare la Chiesa come una madre. Questa risposta gli è piaciuta. Al contrario, la loro accompagnatrice non è riuscita a trattenersi: «Come una madre? Io non avevo mai pensato a questo. Non crede Lei che questo è un po’ vecchio?». No, non si può sapere quello che è realmente la Chiesa se non la si considera come propria madre. È proprio per questo che il prete è chiamato a nutrire una devozione particolare verso la Vergine Maria, la Madre della Chiesa e dunque la sua propria madre.
Abbiamo riflettuto sulla chiamata in se stessa, lanciata da Dio, quello che abbiamo chiamato il versante oggettivo della vocazione. Ci rimane di soffermarci sul versante soggettivo. Due questioni generali si pongono allora: come arrivare alla convinzione che il Signore mi chiama veramente a tale esistenza, in questo caso a diventare prete? Come rispondere a questa chiamata?
Ancora: come sapere a che cosa esattamente mi chiama il Signore? come arrivare a una convinzione che sostenga la mia decisione? Conoscete le risposte classiche che hanno tutte il loro peso di verità: pregare, chiedere consiglio particolarmente nel quadro della direzione spirituale, e soprattutto rendere docile il proprio cuore in modo da renderlo disponibile e aperto alla volontà divina.
Dovrei lasciare da parte il sostegno della comunità — famiglia, parrocchia, movimento, eccetera; da un lato, vediamo che l’accompagnamento fatto da queste comunità è necessario affinché la vocazione non si perda nelle sabbie della solitudine; da un altro lato, sappiamo anche che alcune famiglie cercano soprattutto di scoraggiare queste vocazioni («È un binario morto», diceva una madre di famiglia) e che a volte le altre comunità cristiane esitano a parlarne, anche se le situazioni evolvono in modo più positivo in questi ultimi tempi.
Ancora una volta, la risposta suggerita al giovane Samuele dal profeta Eli ci sembra la migliore: «Parla, Signore, il tuo servo ascolta». Ma appunto, come parla Dio? Egli fa, se lo posso dire, freccia di ogni legno, e ci indica il suo progetto in molte maniere, a volte nei modi più inaspettati. Un libro, un film — qui una lode speciale a The Tree of Life, che è uno dei film più cristiani di questi ultimi decenni — un programma televisivo — negli Stati Uniti si vedono perfino sulla stampa degli annunci pubblicitari che esaltano l’ingresso in seminario o in una casa religiosa — degli incontri determinanti, una testimonianza di preti che ci sembra entusiasmante e degna di imitazione — la tristezza di un prete può essere una contro-testimonianza. Ecco dunque alcuni dei segni oggettivi attraverso i quali il Signore cerca di farci conoscere la sua volontà su di noi. Tutto diventa segno di Dio per chi ha disposto il suo cuore in sintonia con la volontà divina.
Ce n’è uno, però, sul quale vorrei soffermarmi un po’. Il migliore segno resta se stesso! Infatti, è nella conoscenza di se stesso che scopriamo progressivamente che il nostro modo particolare di vivere il nostro battesimo passa obbligatoriamente attraverso tale scelta di vita. Il nostro carattere, il nostro temperamento, le nostre aspirazioni — come dicevamo poco prima — i nostri sogni, in una parola la nostra personalità, sono dei segni del primo discernimento. Il vecchio consiglio che si trovava scritto sul portico del tempio di Delfi non ha perso niente della sua attualità: «Conosci te stesso». Chi non si conosce è incapace di scegliere. Sbagliando su se stesso, sbaglierebbe necessariamente sul suo futuro. Facendo una scelta definitiva, in realtà prenderebbe un impegno per un altro diverso da se stesso: cogliere se stesso prima di poter donarsi. È dunque necessario arrivare a una maturità reale prima di decidersi. È senza dubbio una delle sfide maggiori che la nostra società lancia alla vocazione sacerdotale. Essa che coltiva una forma di indeterminazione, una sorta di immaturità lasciando credere che è meglio rimandare il più lontano il momento della scelta, allo scopo di conservare la propria libertà, o ancora, che nessuna scelta potrebbe essere definitiva e impegnare per tutta la vita. È quanto ho imparato preparando molte coppie al matrimonio: oggi, dicevano, proviamo un sentimento molto forte l’uno per l’altra. Però se domani, come è inevitabile, questo sentimento si indebolisce o addirittura sparisce, cosa farete, chiedevo a loro? La risposta era sempre la stessa: se noi cambiamo noi stessi, cambieranno anche i nostri impegni.
Da quanto ho appena affermato, traggo una convinzione personale: non esiste per ciascuno di noi che una sola vocazione. Il Signore non ci offre un ventaglio di possibilità; noi non ci troviamo a uguale distanza da queste diverse possibilità: una sola conviene veramente. I moralisti ci spiegherebbero che là non c’è materia alla libertà d’indifferenza. La vocazione non è quindi una chiamata che verrebbe dal di fuori di noi stessi e rimarrebbe estranea a noi stessi; no, il Signore ha orientato tutto il nostro essere in vista della chiamata che ci lancia.
Siamo stati concepiti e modellati in tutte le fibre del nostro essere in funzione di questa chiamata. In altri termini, la vocazione non trova in noi degli esseri indeterminati, ma veramente programmati — come si parla di programma in genetica — in funzione di essa. Qui utilizzerei l’espressione agostiniana di predestinazione, ma in un senso diverso da quello originale: riguardo alla nostra vocazione, sì, noi siamo effettivamente predestinati. Bisognerebbe citare qui il magnifico Salmo 139: «La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta; alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza? Se prendo le ali dell’aurora per abitare all’estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra». Una sola chiamata nella vita, non un’altra. Dio chiama, Egli non potrebbe, se lo posso dire, «dischiamare».
Se condividete questa convinzione, vi sentite più a vostro agio per rispondere alla seconda domanda che abbiamo fatto: perché rispondere di sì al Signore? Perché non si può fare altrimenti. Non affatto perché il Signore ci impone la sua volontà al modo di un sovrano arbitrario; possiamo dire di no; ma dire di no sarebbe come rinnegare se stesso, dato che siamo stati preparati per questa missione da tutta l’eternità. Come lo dice ancora la Bibbia, davanti a ciascuno di noi, il Signore ha disposto una scelta: tra la vita e la morte; siamo liberi di stendere la nostra mano verso l’una o verso l’altra (cfr. Siracide, 15, 16-17). Ma scegliere la morte, è veramente scegliere?
Perché rispondere di sì, se il Signore mi chiama a diventare prete? Molto semplicemente, perché si tratta della mia felicità. Essere prete per essere felice. Certo, questa via comporta delle rinunce: al matrimonio (ma non affatto all’amicizia) ai figli (ma non affatto alla paternità spirituale) al prestigio sociale (ma per comunicare la vita stessa di Dio). Per altro, ogni esistenza umana comporta delle rinunce. Essere felice come prete malgrado queste rinunce, o anche a causa di queste rinunce, perché non c’è più grande felicità che dare la propria vita per quelli che si amano. Scegliere di servire, perché servire è un onore.
Per terminare questa riflessione desidererei soffermarmi su un testo particolarmente toccante. Il 18 settembre 1994, Giovanni Paolo II, incontrava i giovani della diocesi di Lecce. Egli parlava loro della vocazione, di ogni forma di vocazione. Questa magnifica meditazione sul legame esistente tra la vocazione e la felicità vale anche per noi: «Il giovane comincia a progettare la sua vita e vive con questo progetto e cerca di realizzare questo progetto, di prepararsi alla sua realizzazione. In altre parole, questo si chiama anche vocazione, perché quel progetto che tu, cara ragazza, caro ragazzo, trovi come tua proprietà viene anche nello stesso tempo da Dio, viene suggerito dallo Spirito Santo, e ci vuole una collaborazione con lo Spirito Santo per identificare questo progetto, approfondirlo, e poi per realizzarlo bene, per trovare la felicità, perché il progetto realizzato porta con sé questa felicità, questa felicità a cui Dio ci chiama. Noi siamo tutti chiamati alla felicità in Dio, attraverso questo nostro progetto che viene anche da Lui. Viene accettato da noi, viene realizzato da noi e poi trova la sua ultima tappa in Dio stesso».
© L'Osservatore Romano 22 luglio 2011