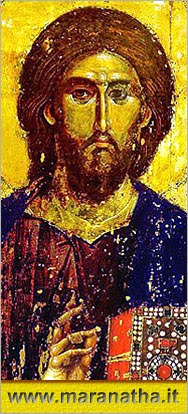Se un problema etico finisce per essere ridotto a problema tecnico
Uccidiamo solo la sofferenza
di Oddone Camerana
Concentrata sugli aspetti giuridici e legislativi del fine vita, la cronaca di questi ultimi anni non ha facilitato la comprensione del fenomeno della domanda crescente di una soluzione accettabile del problema. Magistratura contro legislatura, squilibri sul piano della competenza tecnica tra chi chiede e chi deve rispondere, pressione dei nuovi principi di autodeterminazione, inadeguatezza dello schema giuridico a fronte della flessibilità della prassi delle cure palliative, sono solo alcuni dei temi motivo di tensione che aspettano di venire chiariti.
Nel frattempo la realtà procede e il numero di coloro che per età, solitudine, sofferenza fisica e bisogno temono essere di peso cresce alla ricerca di una soluzione. Ora il fatto di sapere che si può domandare di essere lasciati morire quando il dolore è insostenibile o non c’è più coscienza di vivere, non solo si presenta come una via di uscita che dà sicurezza, ma, di fatto, riduce la richiesta di un intervento che il più delle volte svanisce o si riduce al massimo alla formula codificata dall’uso rivolta al medico a cui si chiede: «Fammi dormire». Sapere che c’è questa possibilità aiuta, rassicura e toglie l’angoscia, un po’ come avviene vedendo la scritta illuminata «Uscita di sicurezza» che nel buio della sala cinematografica indica la via di fuga verso la salvezza, varco di cui probabilmente non si farà mai uso.
Con questo ho formulato solo un esempio di come la lettura di un libro uscito in questi giorni susciti uno sguardo disteso su una materia arroventata (Federica Verga Marfisi, Sospesi. Una lettura antropologica dell’eutanasia, Torino, Fondazione Ariodante Fabretti, pagine 320, euro 20). Merito dell’approccio antropologico scelto dall’autrice, del taglio non dogmatico, contrario agli schieramenti, propenso all’analisi, all’incompiuto, alla sospensione del giudizio, all’indefinito, ma che non per questo rifugge dal chiamare attorno al tavolo della discussione dell’eutanasia la vita, la storia, il dolore e le tecnologie mediche.
A intorbidire le acque e a sollevare dei veti impropri ha certamente contributo, almeno fino a qualche tempo addietro, il ricordo dell’eutanasia nazista, misura praticata nel secolo scorso con un crescendo che a partire dalla soppressione dai malati psichici e degli inadatti è arrivata allo sterminio razziale. Senonché l’eutanasia nazista è un capitolo dell’eugenetica e del genocidio, riguarda il supposto bene di un popolo ritenuto superiore, fa parte di un programma di ripristino di un’etica purificatoria, sacrificale e pagana, e non concerne la dolce morte di un singolo individuo. In pratica parlare di eutanasia nazista equivale a non riconoscere che si tratta dell’usurpazione di un termine.
Altrettanto intricata si presenta la questione di definire il termine stesso. Prima di porre un problema etico l’eutanasia pone, infatti, un problema semantico. Si va dal suicidio dello stoico antico che muore trattenendo il respiro, al rito arcaico dell’accabadora in grado di troncare la vita del sofferente con una mossa sicura, alla legittimazione sostenuta da Thomas More nell’Utopia del 1516, al sacrificio per la patria, alla sedazione del malato terminale, senza scordare altre forme di eutanasia come quella economica nei riguardi dei meno abbienti, quella clandestina, quella infantile e le forme occulte che danno la precedenza a interventi curativi costosi a chi ha più chance di sopravvivere.
Sopprimere o lasciar soffrire? Che si tratti di uccidere o no il cavallo azzoppato, di fare uso della misericordia — il pugnale usato per dare il colpo di grazia al rivale ferito a morte — o della morfina somministrata al sofferente o di uccidere o lasciare soffrire un malato, l’arco dei dilemmi tragici è sterminato, perché si tratta sempre di dover scegliere tra due torti e del fatto che dietro alla richiesta di morire si cela sempre una richiesta di vita. Più che cercare di definire un termine che muta a seconda dei contesti culturali e del non senso dato oggi al dolore e dovuto alla paura di pesare, si tratta dunque di mettere a fuoco un approccio mentale, di interpretare una domanda. Una domanda che preme dietro le istanze sollecitate dalla scienza, dalla medicina e dalla biologia.
Va tenuto conto inoltre il fatto che non è tanto il ridimensionamento del religioso a facilitare la richiesta del fine vita, ma la centralità assunta dal corpo, centralità accompagnata dal riconoscimento crescente dei diritti individuali. Valori come l’inviolabilità e l’indisponibilità della vita devono pertanto vedersela con la pervasività delle tecniche biomediche. Privata di coscienza e di relazioni, una vita artificiale è una vita sconsacrata per la quale il problema etico si riduce a un problema tecnico. In un certo senso è quanto succede nel campo delle intercettazioni telefoniche dove i propositi di tutela della privacy sono messi a dura prova dalle scoperte delle tecnologie che procedono in modo autonomo e inconsapevole e che, come il convitato di pietra, non aspettano il parere di chi orienta le coscienze, tanto meno l’opinione del legislatore o del giurista.
Ciò detto, chiusasi l’epoca in cui la morte era un tabù, epoca dominata dal paternalismo medico, morte e vita sono oggi tornate ad essere questioni anche della collettività. Valori come quello della dignità, ancorché centrati sull’individuo, fanno parte di una cultura globalizzata e sociale e in quanto tale religiosa così da rendere possibile che bioetica cattolica e bioetica laica si avvicinino. Se non si tratta di una rivincita sulla morte, si tratta pur sempre dello sforzo di poter porre termine alla sofferenza senza terminare la vita.
© L'Osservatore Romano 8 luglio 2011