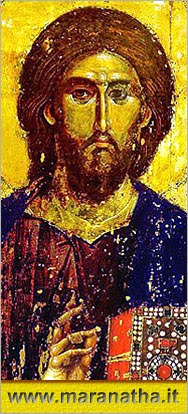Giustino de Jacobis, testimone del Vangelo in Etiopia tra il 1839 e il 1860
La sua metodologia missionaria
La sua metodologia missionaria
Credibilità di un esempio
di Gian Paolo Romanato
Sappiamo poco dei missionari. Eppure sono stati loro a scrivere le pagine forse più belle della vita della Chiesa. Pagine intrise non soltanto di eroico ardore apostolico ma anche di straordinario ardimento e di autentica intelligenza. Fino alla fine dell’Ottocento — e in non pochi casi fino a pochi anni or sono — i missionari si inoltravano da soli in terre sconosciute, avvicinavano popoli ignoti, non disponevano né di aiuti né di carte geografiche.
Dovevano cavarsela in ogni circostanza e davanti a qualsiasi pericolo, imparare lingue incredibili, procurarsi i mezzi di sostentamento, mimetizzarsi in mezzo a gente che li ignorava e spesso li rifiutava, inventare nuove forme di apostolato e adattarle alle situazioni che via via incontravano. Molti di loro, lontani per anni da tutto e da tutti, tagliati fuori da ogni comunicazione, morirono in totale solitudine, senza una mano amica che ne raccogliesse l’ultimo respiro. Eppure da questi uomini, la maggior parte dei quali rimangono ignoti, sono venuti contributi decisivi al progresso delle esplorazioni, della linguistica, della geografia, della cartografia, dell’etnologia, della botanica, della zoologia. Per non parlare di quella che oggi chiamiamo interculturalità. Non è, dunque, solo la storia ecclesiastica ad avere un debito nei loro confronti.
Uno di questi uomini fu Giustino de Jacobis, nato in provincia di Potenza allo scoccare del secolo, nel 1800. Proveniva da una famiglia benestante e a diciotto anni entrò nel noviziato dei lazzaristi. Ordinato nel 1824, trascorse i primi dieci anni del suo ministero operando nelle missioni itineranti del mezzogiorno d’Italia, soprattutto in Campania e Puglia. Poi fu per due anni responsabile della comunità di Lecce, brillando più per zelo sacerdotale che per capacità amministrative, e quindi direttore del noviziato di Napoli, dove giunse mentre era in corso una grave epidemia di colera. Mentre era in questa città maturò il progetto di destinarlo alla missione in Africa.
Per la Chiesa, messa alle corde dall’avanzare della modernità, erano anni difficili, mentre si avvicinavano due appuntamenti drammatici: l’unificazione italiana e la fine dello Stato pontificio. La scelta della linea antiliberale e intransigente da parte di Gregorio XVI (1831-1846) aggravò il conflitto fino a renderlo irrimediabile. Eppure fu questo Pontefice, già prefetto di Propaganda Fide, che riaprì le strade della missione, gravemente compromesse dagli eventi rivoluzionari dei decenni precedenti. Ma il vero stratega della rinascita missionaria in Africa, in Asia, nelle Americhe, in Oceania fu Filippo Fransoni, successore del Pontefice a capo della congregazione di Propaganda, che guidò con sapienza e intelligenza dal 1834 fino alla morte, avvenuta nel 1856.
Fu proprio il cardinale, in visita a Napoli nell’ottobre del 1838, che convinse definitivamente de Jacobis ad accettare di andare in Abissinia, dove questi giunse a metà ottobre dell’anno seguente, al termine di cinque mesi di viaggio allucinante, prima nel Mediterraneo, poi risalendo l’Egitto lungo il corso del Nilo, quindi attraverso il deserto fino al mar Rosso e a Massaua, e poi su per le montagne per raggiungere Adua, che era la meta, a quasi duemila metri di altitudine. In Abissinia, l’attuale Eritrea, trascorrerà i restanti vent’anni della sua vita — salvo un breve ritorno a Roma nel 1841 — che ora possiamo finalmente conoscere grazie allo studio del comboniano Antonio Furioli (Vangelo e testimonianza. L’esperienza di san Giustino de Jacobis in Abissinia, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2008).
In una situazione politicamente e religiosamente difficile, dovendo muoversi fra incessanti turbolenze politiche (conoscerà per alcuni mesi anche il carcere) e la comprensibile diffidenza dell’ambiente copto locale, de Jacobis proseguì e perfezionò l’opera dell’altro missionario lazzarista che l’aveva preceduto, Giuseppe Sapeto, il quale poi lascerà la missione e diverrà uno dei battistrada del colonialismo italiano in quella regione (su di lui si veda ora lo studio di Francesco Surdich, L’attività missionaria, politico-diplomatica e scientifica di Giuseppe Sapeto. Dall’evangelizzazione dell’Abissinia all’acquisto della baia di Assab, Comunità Montana Alta Val Bormida, Millesimo, 2005).
Quale fu l’apporto di de Jacobis alla metodologia missionaria? Come i gesuiti in Estremo Oriente nei secoli precedenti e come farà Daniele Comboni nel vicino Sudan pochi anni dopo di lui, il sacerdote lucano applicò con sapienti adattamenti il metodo dell’inculturazione. Che significa immedesimazione nel luogo in cui si opera, adottandone la lingua, il modo di vivere e di vestire, lo stile, le abitudini, le forme liturgiche. Insomma, come Ricci si era fatto cinese fra i cinesi, come Valignano era stato giapponese fra i giapponesi, come Comboni sarà sudanese fra i sudanesi, così de Jacobis fu abissino fra gli abissini. Di suo aggiunse l’umiltà, la pacatezza dei modi, la disponibilità verso tutti, l’attenzione che pose nell’astenersi da ogni controversia locale, anche teologica, la cura con cui evitò di dare alla sua missione ogni apparenza di privilegio e di prevaricazione. L’esempio più che le parole dovevano renderlo credibile. Nello studio prima citato Furioli riassume così la sua metodologia: mantenere buone relazioni con le autorità locali, tanto civili quanto ecclesiastiche; evitare inutili controversie teologiche; non creare fondazioni missionarie appariscenti e adottare uno stile di vita itinerante, povero, retto, vicino al popolo; tenersi alla larga dalle questioni politiche.
In questo fu perfettamente in sintonia con l’altro grande missionario inviato da Roma nel territorio a sud dell’Abissinia, cioè nell’attuale Etiopia: Guglielmo Massaja. E anche questa figura oggi ci è meno sconosciuta grazie all’opera di Mauro Forno (Tra Africa e Occidente. Il cardinale Massaja e la missione cattolica in Etiopia nella coscienza e nella politica europee, Bologna, il Mulino, 2009).
Sarà proprio Massaja, secondo il mandato ricevuto da Roma, a consacrare vescovo il riluttante de Jacobis l’8 gennaio 1849. Negli undici anni che gli restarono da vivere (morì nel 1860 e le sue spoglie riposano in Eritrea) pose le fondamenta di quella che oggi è la Chiesa cattolica etiope. La causa di canonizzazione fu avviata nel 1904, durante il pontificato di Pio X, e si concluse nel 1975, quando Paolo VI lo proclamò santo indicandolo come una figura esemplare di uomo, di sacerdote e di missionario.
© L'Osservatore Romano 2 agosto 2011